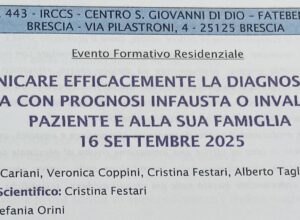La lotta al cancro e il mondo dello sport si incontrano nel progetto Atleti al tuo fianco, con l’obiettivo di raccontare la quotidianità di chi affronta un tumore e di far sentire loro la vicinanza degli sportivi professionisti. Il progetto è patrocinato da aRenBì Onlus ed è curato dal dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo bresciano con diploma d’alta formazione in psiconcologia. Entra a far parte di questa squadra Giancarlo Masini, ciclista paralimpico, medaglia di bronzo ai giochi paralimpici di Rio De Janeiro nel 2016.
Ciao Giancarlo, benvenuto nella squadra di Atleti al tuo fianco; la tua storia agonistica e personale sarà strumento per approfondire alcune tematiche che toccano da vicino le persone che stanno affrontando il cancro. La prima domanda è introduttiva: raccontaci come nella tua vita sei diventato un atleta del ciclismo paralimpico.
Provengo da una famiglia di sportivi appassionati di motocross, io stesso quando avevo solo otto anni ero già un piccolo motociclista e per parecchi anni ho avuto anche la fortuna di fare della motocross il mio lavoro.
Di difficoltà ne ho incontrate tante, di infortuni ne ho avuti parecchi, la paura di farmi male e di rimanere sulla sedie a rotelle è stata sempre presente nella mia vita: non ho mai dato per scontato il fatto di finire la mia carriera rimanendo sano, però uno questi timori li mette poi da parte, cerca di non pensarci troppo.
Nel 1992, a ventidue anni, ho smesso di andare sulle moto da cross a causa di un grave infortunio alla mano destra. Ho dovuto ricominciare la mia vita da capo, perché fino a quel momento la mia esistenza era orbitata intorno al binomio casa/motocross. Ho poi praticato per un paio d’anni il ciclismo, traendone un grande piacere; sono poi tornato alla mountain bike, dove per più di dieci anni ho gareggiato ad alti livelli: sono stato campione europeo, quinto ai mondiali e mi sono divertito un sacco. In seguito a questo ci sono poi stati il triathlon e il duathlon: insomma, si può dire che sono stato uno sportivo a 360 gradi.
Nella mia vita però c’è stato un evento chiave: nel 2012 ho partecipato ad una gara internazionale padre-figlio a Torino, un raduno di vecchie glorie. Durante questa competizione in un salto sono caduto a spalle indietro e mi sono rotto due vertebre: in quel momento è finita la mia prima vita ed è iniziata la seconda. Sono stato dodici giorni in rianimazione: non volevo più mangiare, non volevo più fare niente, volevo solo morire. I medici mi hanno detto che non avrei più camminato, che non avrei fatto più alcun tipo di sport, mi sembrava una cosa inaccettabile. Ad un certo punto però una piccola scintilla si è accesa: c’è stato un piccolo cenno di vita nelle mie gambe, un minimo movimento che mi ha portato a rimettermi in moto, cercando di tirare fuori tutto quello che potevo estrarre da questo infortunio.
I primi anni è stato difficilissimo parlare di sport. Tutti ti possono stare vicino, ma siccome è una cosa che riguarda te, tendi a isolarti, a pensare che sia un problema solo tuo e che gli altri non possano capire. In effetti in parte è così, ma dall’altra parte la gente che ti vuole bene ti sta vicino: grazie a loro e al mio mai sopito amore per lo sport ho ricominciato a fare qualche prova, ho visto che le gambe facevano qualche movimento sulla bici sui rulli. Il ritorno a casa è stato un’altra tappa molto difficile da affrontare: finché sei all’ospedale sono tutti come te, sei nel mondo dei disabili e non ti senti diverso dagli altri, ma uscire dall’ospedale e ritrovarsi catapultato in quella che prima era la tua normalità è un duro colpo. L’unica cosa che mi ha fatto stare bene in quel momento è stato il miglioramento nella pedalata, tornare a fare qualcosa che facessi già prima: è stato il mezzo che mi ha permesso di farmi riavvicinare dalla normalità, il mio ritorno alla vita.
In oncologia, l’obiettivo che una diagnosi concede può essere in certi casi la guarigione o in altri la cronicizzazione; in quest’ultimo caso si intende un cancro da cui non si guarisce ma che non peggiora, portando la persona che ne riceve la diagnosi a terapie croniche finalizzate a una buona qualità di vita. Tuttavia, non è emotivamente facile per una persona pensare di non poter guarire mai. Nella tua storia, i medici sono stati categorici, senza lasciarti la speranza di un recupero degli arti inferiori per ripristinare la tua vita precedente. Cosa ti ha aiutato a capire che era possibile ricostruire, con le risorse residue, qualcosa che fosse possibile chiamare “vita di Giancarlo” e che potesse essere accettabile?
Sicuramente in quella difficile fase per me, lo sport è stata un’ancora di salvezza. Mi sono trovato ad affrontare una situazione complessa da immaginare per una persona sana: essere disabili non vuol solo dire che tu non riesci a muovere le gambe, ma implica componenti che sembrano andare a ledere la tua dignità come persona, come se di colpo fossi tornato ad essere un bambino. Hai bisogno di essere spostato, cambiato, pulito: a quarant’anni questa cosa è difficile da accettare. In quel momento mi sono buttato a capofitto nello sport; ciò che mi ha dato la voglia di tornare in mezzo alla gente, di accettarmi, è stato il desiderio di compiere imprese che risultassero tali anche per un normodotato: ho disputato gare, ho vinto una medaglia di bronzo all’olimpiade e ho disputato un mondiale a solo un anno e mezzo dall’incidente. In questo senso lo sport mi ha dato la forza, è stato un aiuto enorme, penso che sia stato una grande medicina.
Parliamo del concetto di forza, perché ci sono degli equivoci che creano delle grossissime difficoltà a chi vive un tumore in prima persona o accanto ad un familiare. Sentirsi dire espressioni come: “devi essere forte, sei sempre stato forte, sono sicuro che ce la farai…” come se ci fosse un obbligo di “essere forte”, non aiuta la persona a sentirsi compresa e a comprendere lei per prima le sue emozioni. È importante capire che la forza non è un dovere ma una risorsa da cercare, trovare, a volte rendersi conto di non possedere momentaneamente. Vorrei che tu ci raccontassi un giorno in cui ti sei sentito forte e un giorno in cui invece ti sei sentito totalmente in balia della debolezza.
Non c’è stato un solo giorno in particolare, in ogni giornata ci sono tanti momenti in cui ti senti veramente una larva perché non riesci a fare quello che facevi prima. Penso però che sentirsi debole sia una cosa normale e, quando si ha a che fare con una persona che ha avuto un incidente o che sta affrontando un tumore, bisognerebbe evitare espressioni come “devi essere forte”, “devi essere un duro”, “non devi mollare”, perché quella persona è chiamata a ripartire da capo, dalla parte debole, cercando di risalire.
In un momento che ricordo come tragico, avevo cacciato in malo modo un prete che era entrato nella mia camera al solo scopo di portarmi un po’ di conforto; ero particolarmente nervoso perché pochi minuti prima avevo assistito al dolore di due genitori che piangevano per il figlio rimasto tetraplegico a seguito di un banale incidente stradale causato da un tombino. In un momento come quello, qualunque parola mi sarebbe sembrata di troppo, fastidiosa: alcune volte è più importante il modo in cui ci si avvicina, rispetto a quello che si dice. Se il modo è sbagliato, freddo, poco interessato al profondo stato umano che si sta vivendo, non vi è parola che possa essere trovata gradevole, soprattutto se vuole dare per scontato il senso della forza.
Una circostanza molto intensa sotto il profilo della forza è stata invece quando sono tornato a casa dall’olimpiade; giravo nel supermercato sulla sedia a rotelle con le stampelle appoggiate alla spalla e la gente mi riconosceva da questo: in quel momento mi sono dimenticato di essere un disabile, è sparito lo strano senso di vergogna che provavo rispetto alle mie evidenti debolezze fisiche. In quel momento, mi sentito forte dentro quanto lo ero prima dell’incidente.
Tra le situazioni più complesse in oncologia per la mente umana vi è l’incontro con una recidiva. Dover affrontare di nuovo un tumore, quando si riteneva di aver completamente archiviato il discorso, porta un’immediata sensazione di sconfitta, di azzeramento. È fondamentale, dopo un legittimo e anche necessario crollo emotivo all’esordio, comprendere che non si ricomincia da zero, ma da se stessi. Dalle proprie forze, debolezze, emozioni, qualità e risorse. Nella tua carriera, più volte hai rimesso a frutto delle abilità tue all’interno di una disciplina e di un contesto diverso da quello di partenza. Raccontaci come sei riuscito in tutte queste occasioni a non sentirti azzerato, facendo delle tue abilità un punto di partenza per un nuovo pezzo di strada.
Penso che una persona debba tenere a mente la sua vita fino a quel momento. Quando ti succedono questi incidenti vai a cercare indietro i momenti più difficili che hai avuto: quando sei stato male, quando hai avuto dei problemi, anche se capisco che in certi casi sia difficile trovare un esempio di pari difficoltà alla situazione che stai vivendo. Tutti gli avvenimenti precedenti ti hanno però insegnato ad arrivare fino a quella tappa del tuo cammino, in un certo senso è come se tutti gli avvenimenti precedenti fossero dei piccoli mattoncini che hanno l’obiettivo di rendere meno alto lo scalino che devi salire. Per questo è basilare ripensare ai percorsi che si sono affrontati: nel momento della nuova difficoltà, non vali zero, vali quel che sei e quel che hai appreso. Da lì, si è chiamati a ripartire.
Il tempo delle terapie nella mente di un paziente rischia di essere percepito come un tempo di totale frustrazione, come una perdita di tempo rispetto alla vita da guarito che aveva e che non vede l’ora di riavere. È utile cogliere che, anche mentre ci si cura, si deve dare valore alla vita e al suo tempo, in tutti quei momenti concessi dallo stato di salute. Nel ciclismo, come reagisce la tua mente quando, in una tappa a cronometro, ti sembra di aver perso del tempo in una fase della tappa?
Voler recuperare il tempo che è perso penso sia la cosa più stupida che possa fare un ciclista, perché quando si viaggia “a cronometro”, si è su un filo sottile che segna il tuo limite: devi essere attento nel controllarlo senza discostarti da esso. Puoi cercare, dove è possibile, di limare il tempo perso senza però allontanarti dalla tua tabella di marcia, che è il costante riferimento per la tua tappa. La tua mente ti chiede di poter dire alla fine della gara “ho sbagliato là ma ho cercato di metterci una pezza”, ma non è questa la chiave per vivere in maniera efficace il tempo della pedalata.
Penso che dagli infortuni come il mio o dalle malattie sia necessario imparare a coltivare la pazienza, come strumento che detta il ritmo della vita quotidiana,anche se capisco che la voglia di guarire e il desiderio di uscire da certe situazioni ti possa far avvertire i secondi come ore. Me ne rendo bene conto quando al mattino sono di fretta: prima dell’incidente per vestirmi ci impiegavo due minuti, adesso ci impiego comunque minimo mezz’ora. Ma proprio per questo, devo imparare a vivere il tempo necessario: se provassi a fare più veloce, non otterrei certo il risultato di uscire con i vestiti in ordine.
Una cosa raccontata come molto fastidiosa dalle persone che vivono un tumore, anche coloro che sono in fase terminale, sono gli sguardi e i dialoghi carichi di pietismo a cui spesso essi si vedono sottoposti. Questo evidenzia la grande differenza tra i concetti di “empatia”, e di “pietà”, solo all’apparenza simili. Vorrei che tu ci spiegassi in quale modo l’essere diventato una persona disabile ha cambiato il tuo modo di vedere le persone disabili e in quale modo lo sport può aiutare la massa a diventare più empatica e meno pietosa nei confronti di una persona che vive sulla sua pelle la realtà della disabilità.
Il momento di svolta nella mia vita è rappresentato dall’olimpiade: avevo davanti agli occhi 4.000 atleti e in quell’occasione ho visto persone che, nella loro quotidianità non erano magari neanche capaci di mangiare in maniera autonoma, prendere in mano gli strumenti della loro disciplina e diventare dei maestri assoluti. Non erano solo disabili a cui era stata data una nuova chance, erano davvero degli sportivi con gli attributi. Penso che, nell’immaginario collettivo, una maggiore consapevolezza riguardo a questa realtà sia arrivata con le Olimpiadi di Londra: sull’onda di quella manifestazione oggi si inizia finalmente a vedere i para-atleti come atleti e non solo più come “poverina quella persona”. Penso che il nostro batterci in questi anni come Nazionale, sia proprio volto a dimostrare che siamo atleti a tutti gli effetti.
Prima delle Olimpiadi di Rio io consideravo lo sport paralimpico come di “serie B” rispetto a quello che avevo vissuto in precedenza, anche vincere una medaglia di bronzo in una di queste categorie era per me cosa da poco. Mi sono dovuto ricredere: nel mio ambiente incontro oggi persone con una forza grande ed un temperamento forte che non avevo mai visto altrove.
Quando vado nelle scuole e sento che veniamo presentati come dei supereroi, io dico ai ragazzi “guardate che noi non siamo superiori: siamo solo persone che vogliono tornare a vivere e farsi rispettare dai normodotati”. Questa marcia in più che vedete in noi ce l’avete anche voi, ma dovete tirarla fuori adesso. È la stessa che noi abbiamo tirato fuori nel momento di difficoltà: non aspettate di essere nel momento più tragico della vostra vita per tirare fuori gli attributi.