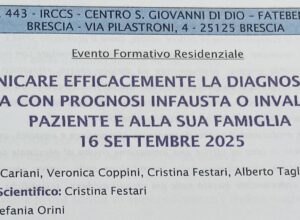Lotta al cancro e sport si incontrano attraverso il dialogo con atleti professionisti che rivivono e raccontano le propria attività agonistica in un’ottica completamente diversa dal solito, che li avvicina a chi sta affrontando un tumore: questo è il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo di Montichiari con DAF in psico-oncologia e patrocinato dalla associazione Arenbì Onlus. Oggi prende parte a questa iniziativa Manuela Leggeri, capitano della Nazionale Italiana di pallavolo femminile campione del mondo nel 2002.
Ciao Manuela, benvenuta nel progetto Atleti al tuo fianco. Oggi faremo con te un percorso speciale: questa iniziativa ha come tema centrale il cancro e la vita quotidiana delle persone che stanno affrontando un tumore. Lo sport si mette a disposizione per parlare di questo e insieme avvicineremo questo tema attraverso la storia della tua vita, personale e sportiva. Per raggiungere questa finalità, cominciamo ascoltandoti raccontarci la tua storia dall’inizio: come è nato il tuo incontro con la pallavolo?
Ciao a tutti, sono Manuela Leggeri, una persona che deve tanto al volley: avevo circa 12 anni, ero alta 1,76m e con un carattere decisamente scarico. Tutto questo mi ha creato dei complessi: camminavo gobba perché i miei compagni erano tutti più piccoli. Il medico consigliò alla mia famiglia di farmi fare dello sport, in particolare il nuoto, ma io con l’acqua avevo un rapporto un po’ particolare. Poi, la rivelazione: Mimì Ayuhara. E quindi scelsi la pallavolo, che mi ha cambiato radicalmente.
Mi portarono vicino a casa in una piccola squadra di prima divisione, il Priverno. Il primo impatto fu bellissimo: entrammo in palestra e vedemmo la prima allenatrice, Stefania Rizzi (che è diventata poi la mia seconda mamma) che allenava la prima squadra, io fui mandata con il secondo allenatore per provare con altre ragazzine. Immediatamente dopo, il secondo allenatore chiamò la Rizzi e le disse testualmente che ero più brava di lui. Lì le cose sono cambiate subito: ho iniziato a fare quattro allenamenti a settimana più le partite sabato e domenica. Tutto questo a 12 anni e mezzo. Ovviamente, ho dovuto sacrificare tutto il resto: niente serate, niente compleanni, niente gite. A 15 anni io ero già fuori casa. Sono passata dalla serie D alla serie A e la domanda che mi sono fatta è stata: “ma io cosa ho a che fare con queste persone?”. Le sentivo appartenere ad un altro mondo che non mi rappresentava ancora ancora. Mia madre mi seguì a Roma e quando lei non poteva esserci, mio padre veniva e si occupava di me. La mia vita era già tutta consacrata alla pallavolo e, nonostante le difficoltà, non ho mai mollato.
Confrontarsi con la tentazione di mollare è un sentimento che chi sta affrontando un tumore conosce benissimo, perché spesso le difficoltà quotidiane, il dolore, la paura sono avversari molto grandi, per affrontarli occorre trovare motivazioni altrettanto potenti. Tu alla fine non hai mollato: cosa ti ha aiutato a tenere duro?
In effetti non ho mai ceduto, perché c’era qualcosa dentro di me che mi diceva di continuare questo impegno anche quando mi sembrava che la vita da quindicenne mi scorresse a fianco. Io ho avuto una grande fortuna: il sostegno incondizionato dei miei genitori. Loro mi hanno sempre lasciata libera di scegliere dove andare a giocare, senza mai condizionarmi nelle scelte. Sebbene mi renda conto che sto parlando di difficoltà diverse da quelle di un tumore, e lo posso dire con la consapevolezza di chi l’ha vissuto da molto vicino, questa vita è stata comunque costellata di sacrifici e di rinunce. Andando via di casa a quindici anni, il tempo degli affetti e della famiglia andava cercato e creato negli spazi liberi, non si presentava da solo. Per gli amici era ancora più complicato, questa non è una cosa facile per un’adolescente. Però dentro di me avevo la grande motivazione di un traguardo da tagliare, di un obiettivo da concretizzare: questo mi ha spinto ad accettare tutto quel che era necessario per raggiungere quel che volevo.
Per chi sta affrontando la chemioterapia, ci sono giornate in cui gli effetti collaterali impediscono di fare qualsiasi cosa e altre giornate in cui si ha la possibilità di condurre una vita quasi normale. Nelle situazioni di recupero, i pazienti riferiscono di riscoprire il senso della libertà, ad esempio, di muoversi, di mangiare qualcosa, di avere recuperi di energia per prestare attenzione per guardare un film o leggere un libro. Ci sono delle situazioni nello sport che limitano la libertà individuale, e che una volta concluse ti fanno gioire di averla riacquisita?
Alcune volte con le compagne di Nazionale restavamo in ritiro anche per venti giorni consecutivi; una volta che si poteva uscire varcando il cancello, io percepivo la sensazione di libertà di poter fare le cose che fanno tutti, come bere un aperitivo o passare mezza giornata al mare. Al tempo stesso, io posso dire di aver vissuto una favola con la mia vita da giocatrice professionista, dove ho potuto coronare un sogno, e forse perfino di più. Diventare capitano di quella Nazionale, vincere un Mondiale, partecipare alle Olimpiadi, non c’è sacrificio che non abbia avuto senso per raggiungere tutto questo. Ma quando uscivo da quel mondo, mi ritrovavo nella vera vita, nella quotidianità di ogni essere umano dove i problemi erano ben altri. Nel 2003 a mio padre è stato diagnosticato un tumore, non è stato facile convivere serenamente nei due mondi; ti rendi davvero conto che ciò che tu chiami sacrificio per un obiettivo sportivo, non è nulla rispetto a situazioni gravi della vita.
Lottare contro un avversario difficile è un paragone valido sia per lo sportivo che per la persona ammalata di cancro. Ti è mai capitato di percepire che molte delle tue doti di carattere nello sport le avessi ereditate da tuo padre, osservandolo lottare e standogli vicino nella battaglia contro il tumore?
Senza alcun dubbio, è proprio così: noi siamo sempre stati entrambi testardi e in questa battaglia ne ho avuto ulteriore conferma. Nel 2003, dopo l’arrivo della diagnosi, arrivai in Nazionale e dissi alle mie colleghe che non potevo essere la Manu che conoscevano. Io quell’estate l’ho vissuta molto male, perché da fuori sono stata giudicata come quella che si era montata la testa; questo giudizio non toccava l’aspetto puramente sportivo ma quello umano, che fa ancora più male. L’estate successiva c’erano le Olimpiadi di Atene 2004 e a Natale c’erano le qualificazioni; io chiesi espressamente di non essere convocata per stare vicino a mio padre. Lui vedeva che non stavo bene e mi aveva suggerito di mollare la Nazionale, ma io dentro di me mi ero promessa di cercare con tutte le mie forze di andare alle Olimpiadi e solo dopo mi sarei ritirata dalla Nazionale. Glielo confidai e lui mi rispose: “Allora lo voglio leggere sul giornale!”.
Come si svolse quel tuo percorso per raggiungere questo grande obiettivo personale?
Prima delle Olimpiadi c’era il Grand Prix: la prima settimana io sono tra le dodici, mentre la seconda e terza settimana resto in tribuna. Non era certo bello ma io non mi scoraggio facilmente. L’ultima settimana rientro nelle dodici al termine consegnano le convocazioni ufficiali: ero nella lista. Vado subito in ospedale e lo vedo che legge la Gazzetta in lacrime e mi dice: “Abbiamo vinto, eh?”. E io: “Adesso devi vincere tu!”.
Anche più avanti nel tempo, in un’intervista del 17 marzo 2013 subito dopo la vittoria della Coppa Italia, facevo riferimento a due persone che stavano giocando la partita della vita al di fuori dei campi di pallavolo. La prima era Sara Anzanello che stava aspettando un trapianto di fegato, l’altra era mio padre che iniziava, proprio il giorno dopo, la sua ennesima partita con un ciclo di chemioterapia. Quella “sua” partita divenne, proprio per sue parole, la “nostra” partita. Ed è importante dire “noi”, perché nel momento in cui stai cadendo c’è qualcuno che è lì che può prenderti la mano, anche solo per accompagnarti. La presenza delle persone vicine è fondamentale. Una sera che mio padre stava veramente male, mi disse che non ce la faceva più e che voleva interrompere il ciclo delle chemioterapie. Ed io gli ricordai che non doveva mollare, ma non solo per lui, ma per noi, perché eravamo una squadra. E anche quando scoprimmo che stava andando incontro alla fine, lui riuscì ad unirci ancor più di quanto non lo fossimo. Nella fatidica ultima mattina, pur non essendo molto credente, mi disse che doveva prepararsi perché era già con gli angeli. E noi eravamo con lui.
I pazienti e i familiari che vivono un percorso terminale vengono guidati con la psico-oncologia per non farsi annichilire dalla potenza devastante della malattia che si impadronisce della direzione della vita. Il percorso che affrontano li rende capaci di diventare una superficie di rimbalzo contro questa bomba, esattamente come un muro.
Nel fondamentale della pallavolo il muro è esattamente quello che stai dicendo, ovvero la capacità di opporre un piano di rimbalzo nello spazio e nel tempo giusti perché l’attacco, anche il più potente, possa essere neutralizzato. E non c’è solo il muro punto, quello che fa lo splendido suono del “Tu-tum!” che significa pallone a terra; c’è anche il muro che sporcando l’attacco permette alla difesa di tenere alto il pallone, c’è il muro che obbliga gli avversari a rigiocare l’attacco e anche il muro che, senza toccare la palla, spinge l’attaccante a schiacciare fuori. Senza dubbio è stato il mio fondamentale preferito e l’ho sempre usato come scudo, come se scegliessi chi entra nel mio cerchio e chi no. Conoscevo la forza dell’avversario e lo attendevo, prima o poi dovevo murare quella giocatrice. Su dieci attacchi uno passa, l’altro te lo tocco, un altro lo difendiamo facile, ma quello più importante lo chiudo io. Quando abbiamo vinto il mondiale nel 2002, mi torna in mente il flash della semifinale contro la Cina, chiusa dal mio muro. Mi ricordo perfettamente quel momento perché per un centrale c’è ancora più soddisfazione: nell’istante in cui la palla è stata alzata in posto 4, dentro di me c’era questa voce “devo murarla”. Sono andata in alto e “Tu-tum!”, muro secco e si va in finale. E, facendo un paragone con la malattia, ti posso dire che anche mio padre ha murato bene, e noi con lui. Anche se si va in difficoltà, anche se si sente la potenza devastante della malattia e del lutto. Ma abbiamo murato e continuiamo a murare, insieme, uno vicino all’altro tutti compatti, come nei muri a 3. Si vede che è un fondamentale che abbiamo proprio nella nostra indole.
Dopo quel punto che ha deciso la semifinale con la Cina, in finale avete affrontato la nazionale statunitense, corazzata dell’epoca e imbattuta nel torneo. Come si affronta una sfida che pare impossibile ma la cui storia deve ancora essere scritta?
Io ragiono così: un punto alla volta, solo un punto alla volta, che equivale ad un piccolo passo. E in questo percorso non sei da sola, la squadra è con te ed è fondamentale perché se hai un gruppo affiatato, basta uno sguardo per superare insieme una difficoltà. Ed è avvenuto anche in quel mondiale: noi avevamo bisogno di una persona che non stava rendendo come doveva, e ancora mi ricordo le riunioni in stanza tutte insieme dicendole che il suo apporto era fondamentale. Quella persona è venuta fuori, eccome se è venuta fuori, ha portato tutto il suo valore proprio nel momento decisivo. Ed insieme abbiamo vinto, battendo gli USA contro ogni pronostico: l’Italia era campione del mondo per la prima volta nella sua storia. Un passo alla volta, e tutte insieme.
Spesso la paura induce a temere esiti negativi e nefasti: è importantissimo guidare la mente dei pazienti nella distinzione tra dato reale e proiezione della paura. È difficile in quei momenti pensare che la propria vita possa avere ancora le pagine più belle da scrivere in un futuro non immediato ma successivo alla malattia, eppure molti sono i pazienti che possono testimoniare questa esperienza. Se a te avessero dato una penna per scrivere la tua storia sportiva a 15 anni, con le tutte le paure legittime del grande salto che stavi compiendo, saresti stata in grado di scriverla così bella?
Mai avrei immaginato di vivere quello che ho vissuto e posso dire che, per mia esperienza personale, le cose più belle capitano quando meno te lo aspetti. La vita è andata oltre ogni mia possibile aspettativa, se oggi ripenso a me a 15 anni non avrei avuto neanche il coraggio di scrivere per me quello che la realtà ha poi concretizzato. A volte è proprio così, non sei in grado di prevedere le svolte positive della vita, ma bisogna farsi trovare pronti anche a questo.
Grazie Manuela, tra le cose splendide che hai fatto resterà anche questa testimonianza, che è un grande aiuto per chi oggi sta affrontando un tumore in prima persona o accanto a un familiare. Ci hai messo a disposizione la tua vita, la tua mente, il tuo dolore e il tuo coraggio: da oggi sei un’Atleta al fianco di chi sta battagliando contro il cancro, come Leggeri con tutta la tua storia sportiva ma soprattutto come Manu, una splendida ragazza che sa murare gli attacchi che la vita l’ha chiamata ad affrontare.