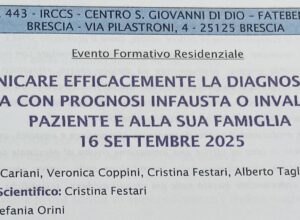Parlare di cancro in maniera libera con sportivi professionisti, ponendo la luce su aspetti della quotidianità di chi sta combattendo un tumore mentre si dialoga di sport: questa è la scommessa che lancia il progetto “Atleti al tuo fianco”. L’iniziativa è guidata dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con DAF in psico-oncologia e patrocinata dall’associazione Arenbì Onlus. Entra a far parte di questa squadra di atleti Eleonora Lo Bianco, la più decorata pallavolista italiana della storia: vincitrice di un Mondiale, due Europei, due Coppe del mondo e una Grand Champions Cup con la maglia della Nazionale Italiana, con la quale ha collezionato 536 presenze.
Ciao Eleonora, benvenuta nel progetto “Atleti al tuo fianco”; la tua carriera sportiva e la storia della tua vita ci offriranno lo spunto per raccontare aspetti della quotidianità di persone che stanno affrontando il cancro. Per cominciare, raccontaci qualcosa di te partendo da lontano, per conoscerti meglio: chi sei tu Eleonora Lo Bianco, con e senza la pallavolo?
Ciao a tutti, io sono Eleonora Lo Bianco, una persona abbastanza introversa, anche se lo ero molto di più da piccola. Quando ho cominciato a praticare uno sport di squadra, il mio carattere si è plasmato tantissimo; dall’età di 8 anni ho iniziato a giocare a pallavolo e questa è stata la mia passione per tutta la vita. È uno sport di cui mi sono innamorata subito, in cui ho dovuto mettermi in gioco sotto tanti punti di vista, sportivi ma anche caratteriali; da molto chiusa ed introversa ho dovuto trasformarmi in una persona che si doveva rapportare con gli altri e lavorare ogni giorno con un gruppo di persone completamente diverse da lei. Questo mi ha aiutato moltissimo e credo che mi abbia cambiato completamente perché ora sono una donna che ha imparato parecchio dallo sport. Questa passione è nata giocando con una mia carissima amica sotto casa, poi mio papà ha trovato un corso di minivolley e da lì ho cominciato a giocare, senza più smettere.
Una persona che riceve una diagnosi di tumore maligno si trova ad affrontare molte emozioni differenti contemporaneamente. Tra queste, vi è la paralizzante sensazione di non essere pronta, di non essere capace ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà. Mantenere la lucidità della mente è fondamentale per costruire un percorso che avrà sì difficoltà e cambiamenti, ma che va affrontato passo dopo passo, giorno per giorno, attuando con la psiconcologia le contromisure che evitino la paralisi del pensiero. Nella tua vita sportiva e personale, ti è mai capitato di affrontare la sensazione di non essere all’altezza di un percorso che ti venisse chiesto di intraprendere?
Mi è capitato sì, tantissime volte nello sport e nella vita. Sono una perfezionista e questa è secondo me una dote, perché ti permette di divenire molto caparbia in quello che fai per pretendere sempre la perfezione. Questa perfezione però non la si ottiene mai, quindi è un continuo mettersi in gioco per provare a raggiungerla. Lo sono stata nella vita e nello sport, mi sono sempre sentita una “non all’altezza”. Io nel 2010 ho avuto un tumore al seno, quindi conosco questa situazione e ho ragionato esattamente nello stesso modo. Ho cercato di darmi degli obiettivi, dopo un primo momento di shock totale. Ho cercato di utilizzare quello che avevo appreso negli allenamenti, nella partita, nell’alimentazione sportiva, nel pre-gara: organizzare la mia mente attraverso degli schemi. Certo non è stato facile: mi sono sentita come fosse esploso un tuono assordante in un giorno di sole: da un momento all’altro ti arriva una diagnosi che non ti ha mai lontanamente sfiorato, perché alla fine è così che arriva. Tu dici “ma perché? e ora cosa faccio?”, e quindi crolli. Ma poi mi sono detta che fosse necessario affrontarla come quando ero in una partita difficile, in una situazione diversa nella quale non mi sentissi comunque pronta o all’altezza. Ho cercato di utilizzare quegli strumenti che mettevo a frutto nello sport, per affrontare il tumore: ho rimesso tutto quello che avevo imparato dentro alla malattia.
La reazione più istintiva delle persone in terapia oncologica è di programmare una sorta di “pausa” dalla propria vita abituale per affrontare le cure, per poi ripartire a costruire. In realtà, l’obiettivo reale è rendersi conto di quanto importante sia la qualità della vita, sia fuori dalla terapia, sia durante le cure: effettuare delle rinunce sarà necessario, ma non si mette in pausa la propria vita. La fase delle terapie non è un’attesa passiva, ma è un periodo comunque attivo nei confronti di se stessi, della propria capacità di offrirsi del bene, del costruirsi e rinforzarsi mentre si effettua ANCHE un percorso di malattia. Per te dover fermare la tua attività sui campi da pallavolo, è stata una messa in pausa in attesa della ripresa o una modifica attiva delle tue abitudini?
Quando ho ricevuto la diagnosi di cancro, mi è stato subito chiaro che non volessi davvero fermarmi, altrimenti sarei rimasta schiacciata da questa pausa forzata e dalle relative paure. La diagnosi è arrivata a fine novembre 2010, dopo il mondiale, quando ero da poco rientrata nella Foppapedretti Bergamo. Io non volevo nemmeno pensare di dover stare ferma, ma mi hanno operata e quindi ho dovuto accettarlo, sono seguite le terapie e quei tempi ho dovuto affrontarli. Il prof. Veronesi mi aveva detto anche che c’era la possibilità di un’asportazione completa dei linfonodi, cosa che non mi avrebbe più concesso di giocare; io pregavo, dicevo “speriamo bene”, ma nel frattempo tenevo chiaro il mio obiettivo di riprendere l’attività. Sono tornata subito a Bergamo e, praticamente, ho svolto la solita vita pur senza allenarmi: per i primi giorni andavo in palestra e guardavo le ragazze; ero in una veste diversa, ero con loro ma davo una mano da fuori, però ero lì, presente per loro mentre loro erano presenti per me. Mi dicevo che stessi continuando a fare parte di quella squadra e che sarei tornata a farne parte anche sul campo, prima o poi. Passavo quindi ogni giorno tra di loro senza allenarmi, dopo la radioterapia: partivo alle 6 di mattina, andavo a Milano, facevo radioterapia alle 9, tornavo indietro e mi recavo in palestra per fare dei piccoli esercizi, compatibilmente con la cicatrice e alle conseguenze della radioterapia. Non potevo vestirmi sportiva perché avevo il seno con una bruciatura, era abbastanza difficoltoso, ma comunque vivevo la stessa routine sportiva che avevo sempre vissuto. Questo mi ha aiutato a sentirmi normale e viva, non soltanto ammalata. Mi stavo curando, facendo un percorso che mi avrebbe portato poi a ritornare in campo, non era una pausa in attesa del rientro.
Un tranello spesso presente nella vita delle persone che sono guarite da un tumore, è sentirsi orgogliosamente pronte a poter ritornare quel che si era prima della neoplasia. Insieme alla felicità di poterlo fare, si possono presentare tanti aspetti per i quali emerge il contrasto con le aspettative, perché non si è più esattamente le stesse persone di prima. Alcuni dolori e cicatrici possono rimanere, la paura della recidiva va messa sotto controllo con gli esercizi: ci sono tanti elementi per i quali bisogna essere pronti non a ritornare, ma ad evolvere. Tu, quando sei rientrata sul campo da pallavolo, il tuo obiettivo è stato tornare la giocatrice che eri prima dell’intervento?
Una volta finite le terapie, non l’ho più sentita dentro di me la donna di prima, ma ho avuto dei momenti in cui mi ci sono confrontata e mi è andata male. I momenti negativi ci sono stati, anche le paure. Io ho avuto un periodo molto lungo dopo questa diagnosi dove ogni minima cosa che sentivo sul mio corpo, automaticamente per me era un tumore. Quindi, mentalmente, sono un po’ crollata, ma combattevo tutti i giorni contro questa sensazione. Devo dire poi che non ho potuto mai sentirmi quella di prima, perché mi sentivo molto osservata come “quella che aveva un tumore” e a volte mi guardavo io stessa e mi vedevo come “quella che ha avuto un tumore”. Per molto tempo ho fatto fatica a guardare il mio seno, è stato operato, ha fatto una quadrantectomia devo dire anche molto buona, non si vede così tanto anche a distanza di anni, però ho dovuto assolutamente affrontare questi momenti di difficoltà, e non sono affatto facili. Però, ho ritrovato una tranquillità mia con un pochino di tempo perché poi, rimettendomi in gioco, ho riconosciuto che non ero quella di prima, ma potevo, lo stesso, essere quella giocatrice, quella persona che, pur avendo avuto una quadrantectomia, pur avendo affrontato un cancro, era diversa ma era sempre lei. Sembra contraddittorio ma è esattamente così. Ciò che sei, non dovrebbe essere una certezza solo per il confronto con ciò che eri; spesso siamo allenati a questo termine di paragone, ma alcune volte la tua evoluzione è così grande che ciò che sei lo devi cercare dentro di te, trovarlo nel presente ed esprimerlo.
L’idea di dover essere forte rischia di essere un’ossessione controproducente: alcune volte è fondamentale essere deboli, essere semplicemente umani di fronte a delle difficoltà. Il modello di forza a tutti i costi crea degli squilibri tra le proprie sensazioni intime e le aspettative esterne, ed è un concetto che non riguarda solo la persona che riceve la diagnosi, ma tutto il suo nucleo familiare. Espressioni come “devo essere forte per lei”, sembrano dei sostegni ma, in realtà, alimentano un dialogo poco reale fra persone molto vicine, che possono lasciare crateri di rammarichi successivamente. Tu hai mai sentito il dovere di essere forte per qualcuno, rispetto a quello che realmente sentivi dentro?
Io ho avuto questa sensazione di dover essere forte all’inizio, perché mi dava fastidio vedere la mia famiglia, le persone che avevo di fianco a me stare male. Questa impostazione mentale però non è durata tanto: prima di entrare in sala operatoria sono scoppiata e mi sono detta “come posso prendermi cura di loro quando prima di tutto io devo prendermi cura di me stessa?”. Ho abbandonato questo dovere e mi sono data degli obiettivi, che potessero semplicemente aiutarmi a stare meglio. Quando ho visto la cicatrice, quando mi hanno comunicato che dovessi affrontare anche delle terapie ormonali, sono andata un po’ giù; ma mollare quella sensazione di dovere essere a tutti i costi vista come forte mi ha aiutato a capire meglio quali fossero i reali obiettivi e le vere emozioni di chi mi stava vicino.
E nella tua vita sportiva, nel corso della quale hai vestito la maglia della Nazionale Italiana 536 volte, la sensazione di dover essere agonisticamente forte mentre rappresentavi molte altre persone, è stata un ostacolo o uno stimolo?
Per me è stata una responsabilità. Io ho sempre sentito l’onore della maglia, soprattutto giocando con la maglia della Nazionale perché rappresenti il Paese, ma anche con quelle dei club in cui ho militato. Non ho mai percepito una sensazione di dovere che mi mettesse una pressione o una difficoltà. Avevo delle pressioni positive come tutti gli atleti, perché avevo degli obiettivi e volevo portare in alto l’Italia, così come volevo vincere con la mia squadra quando giocavo con il club. L’ho sempre vissuta come uno stimolo e un obiettivo, non un dovere.
Vivere le tappe di un percorso oncologico con lo spirito sintonizzato verso piccole e grandi sfide quotidiane, non è sempre facile. Tuttavia è necessario allenare la propria mente a comprendere che la durata di un lungo periodo di cure non ha come unico obiettivo la guarigione finale, ma un sistema molto più complesso di piccoli passi da compiere uno alla volta. Questo aspetto, se non si è ben aiutati, può innestare una pericolosa sensazione di sfiducia, data dal rimettersi in discussione per raggiungere obiettivi che quando si era in salute erano automatici. Nell’ultima stagione pallavolistica, a causa di un problema alla spalla, hai dovuto incominciare a giocare a volley da mancina, usando la mano sinistra in luogo della destra come avevi sempre fatto. Non ti sei mai sentita umiliata dal non saper fare cose molto semplici proprio tu, che sei tra le migliori pallavoliste della storia del nostro sport?
Effettivamente è stato stranissimo, non mi trovavo con questo nuovo fondamentale da mancina, è come imparare a scrivere con la sinistra dopo che hai sempre usato la destra. Anche solo andare in battuta e mettermi con l’altra gamba in avanti, dovevo ripeterlo duecento volte e poi, anche quando mi lanciavo la palla, se sbagliavo di mezzo millimetro, non riuscivo a colpirla: improvvisamente, ero una dilettante alle prime armi, mi sentivo strana e fuori luogo. Alla prima partita mi sono detta “devo accontentarmi di metterla di là della rete, perché questo è il mio obiettivo”, non potevo battere forte. Una cosa mi ha aiutato molto, una mia compagna mi ha detto: “quando hai fatto la prima battuta avrei voluto abbracciarti” perché lei ha visto la mia difficoltà nel ricostruire un fondamentale della pallavolo, dopo vent’anni: sembravo una ragazzina che non sa giocare e, quando ha detto così, io mi sono resa conto del mio sforzo, di quanto avessi fatto per riuscire ad essere in campo. Non era più importante che la battuta fosse piano, ma che io fossi in campo e a quasi 40 anni avessi trovato un nuovo modo di stare in partita pur avendo un problema. È stata un’ennesima sfida, una delle tante che hanno riempito la mia vita.