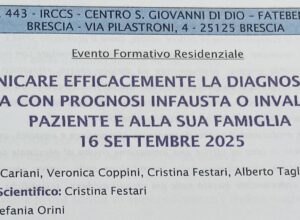Lotta al cancro e sport si incontrano attraverso il dialogo con atleti professionisti che rivivono e raccontano le propria attività agonistica in un’ottica completamente diversa dal solito, che li avvicina a chi sta affrontando un tumore: questo è il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo di Montichiari con DAF in psico-oncologia e patrocinato dalla associazione Arenbì Onlus. Quella che segue qui sotto è la testimonianza di Paola e Francesca, rispettivamente madre e sorella di Federico Luzzi, tennista top 100 scomparso a 28 anni per le rapide complicanze di una leucemia mieloide acuta. Questa intervista ha un andamento diverso da ogni altra, nella sua riproduzione scritta è stata preservata la forma di dialogo dell’incontro straordinariamente piacevole a casa di Francesca ad Arezzo.
Benvenute Paola e Francesca, benvenuto attraverso voi anche Federico. Proprio a te Francesca voglio fare la prima domanda, perché tu ci possa avvicinare a tuo fratello nel percorso di questa iniziativa. Raccontaci da sorella delle cose che solo le sorelle sanno, raccontaci chi era Federico, dagli occhi di sorella maggiore di quattro anni, nel momento storico che tu ritieni più opportuno raccontarci.
Francesca : Ti voglio raccontare l’esperienza del Foro Italico del 2001. Contro ogni pronostico, Federico entra in tabellone. Nello stesso periodo aveva appena firmato un contratto importante con una nota casa di moda che gli aveva disegnato una grande quantità di vestiti sia da tennis che “da passeggio”. Federico mi manda un messaggio: “Vieni a Roma! Vieni a Roma!”. Io all’epoca avevo 25 anni, faccio la mia valigia con lo stretto necessario e arrivo tra mille difficoltà (sciopero dei treni, ritardi) al Foro. Mio fratello subito mi aveva mandato ovunque poiché tutti i compaesani aretini, non appena seppero che era entrato in tabellone, volevano assolutamente avere un biglietto ed io mi ero ritrovata ad andare ad elemosinare, da tutti i giocatori che non avevano parenti lì, dei biglietti. Un giorno mi dice che è arrivata della roba e devo recarmi subito in albergo. Arrivo all’hotel e quello che ho trovato davanti sembrava essere il risultato di un’esplosione nucleare: cellophane, vestiti, scarpe, fogli dappertutto. Ho passato una settimana a riordinare quella stanza! Federico mi chiede dove avrei dormito. “All’EUR” risposi. E lui: “Ma come all’EUR? Ci vuole un’ora e mezza di macchina! Ti conviene tornare ad Arezzo! Dai, dormi qui”. Come avrei potuto dormire in quel luogo bombardato? Il giorno dopo, dalla paura di arrivare tardi, ci alziamo alle 6 per arrivare alle 9 al Foro Italiano. Quel giorno Federico vinse la prima partita. E mi disse: “Ora non puoi andartene. Devi stare qui”. Io che avevo proprio lo strettissimo necessario, ho quindi deciso (decisione un po’ forzata) di rimanere lì con lui. E ho passato una meravigliosa settimana a lavarmi i vestiti, diventando matta per trovare i biglietti, chiedendoli ai giocatori stranieri. Ad un certo punto, tutti mi riconoscevano da lontano: “È la sorella di Federico Luzzi! Dalle i biglietti!”. Federico era questo, per certi versi, un ragazzo folle che, entrando in campo, buttava giù gli stadi. Alle sue partite c’erano tantissime persone e, ogni volta che vinceva, venivano giù gli spalti, un vero e proprio delirio. È arrivato fino al terzo turno. Mi ricordo, andammo a cena ai Canottieri, e tanti altri eventi. Però Federico era sempre Federico, era il ragazzo che andava in giro a torso nudo al Foro Italico e tutti lo salutavano, gli battevano il cinque. Quella è stata un’esperienza veramente meravigliosa.
Paola, una delle domande frequenti che i pazienti si pongono quando si mettono nelle mani di un oncologo, di un’equipe, di un ospedale è: “ma io sarò nelle mani giuste per fare questo percorso?”. La psico-oncologia ti fornisce gli strumenti per gestire il dubbio, che altrimenti diventa un nemico insidiosissimo, molto sottovalutato. Io ti faccio una domanda sportiva. Tu, da madre e voi da genitori, immagino abbiate poi scelto le persone che dovessero prendersi cura della crescita sportiva di Federico. Come avete affrontato i dubbi riguardo all’affidabilità di chi ne avrebbe curato la crescita agonistica?
Paola: Mi fai notare adesso con questa domanda un percorso parallelo del quale non avevo mai percepito la similitudine, perché io sono una sostenitrice in campo medico del non chiedere quaranta pareri, massimo due. Poi ti fidi e ti affidi. Federico è il classico esempio di come non si riesca ad arrivare ai vertici della top10 nel tennis passando da Bertolucci, a Smith, a Magnelli, a Rianna, a Barazzutti, quando i nostri grandi tennisti sono stati Seppi con Sartori tutta la vita, Volandri con Fanucci tutta la vita, e ti potrei nominare altri giocatori e giocatrici, come Errani, Pennetta, Vinci che sono state con il loro coach per 10-15 anni. Quindi è la riprova che trovare uno che crede in te, al quale tu ti affidi, rinforza la tua capacità di rendimento e secondo me, nello sport, come nel campo medico, sono due cose che viaggiano in parallelo. Quando mi capitano, o per AIL o per altre questioni personali, persone che mi chiedono da chi vado, dove vado e quanti ne trovo, io dico sempre che bisogna scegliere e fidarsi. Federico ha avuto, a parte il grosso infortunio alla spalla che ha precluso la sua carriera, un altro handicap di cambiare ogni anno un allenatore. C’è stato anche Bollettieri, in mezzo, ora che mi ci fai pensare, che è un guru. Federico è morto con degli enormi progetti in testa, per fortuna, perché a 28 anni lui era allenato da Alberto Castellani, che è una persona stupenda, di cultura e di profondo credo nell’arricchimento personale, non solamente un coach. Federico mi aveva detto che gli ci era voluto tanto ma aveva finalmente capito quale era quel quid che gli doveva far scattare quello che purtroppo non è scattato con il canto delle sirene che gli dicevano: “Tu sei Luzzi, hai talento, vai!”. Lui l’ha capito tardi, ma per fortuna, so che può sembrare una bestemmia, quando è morto era pieno di progetti, perché aveva finalmente capito, anche se aveva 28 anni, che cosa gli mancava attraverso Alberto Castellani: era pieno di fiducia, sapeva di poter fare grandi cose. Era tornato 100 del mondo e negli ultimi 4-5 anni da tennista avrebbe potuto fare il salto che non aveva potuto effettuare proprio perché era stato seguito da troppe persone.
Francesca, uno degli aspetti che mina di più l’umore quotidiano di chi sta affrontando il cancro è il timore di essere recisi da tutte le situazioni che con il tempo si sono costruite sotto il profilo degli affetti, delle relazioni e delle abitudini quotidiane. Dalle parole di tanti tennisti ho percepito il tennis come un grande circuito che un po’ ti rapisce, soprattutto dalla condivisione quotidiana con le persone e gli affetti con cui si è cresciuti. Tu hai mai avuto la sensazione che Federico, scegliendo di giocare a tennis nella vita, avesse vissuto il taglio dei legami con i suoi amici storici?
F: Io penso che fosse un predestinato per questo sport. A lui piaceva farlo e ha accettato le solitudine dei tornei, come arrivare a Mosca alle due di notte, caricarsi la borsa in spalla ed andare in albergo, solo come un cane, per guadagnarsi una bazzecola che ti serve solo a ripagarti il biglietto aereo. Penso che Federico sia stato molto solo anche se, grazie al telefono, manteneva un certo legame con gli amici nei circuiti. Forse si trattava di una grande famiglia itinerante che girava. Sicuramente questa situazione gli pesava, però la passione ha fatto il resto.
P: Federico era un grande narcisista. Quando vinse i Giochi della gioventù aveva 13 anni e mi chiamò dicendo che gli stavano chiedendo gli autografi. Queste luci della ribalta che lo illuminavano, per quanto ne so io, ripagavano i suoi sforzi. Quando siamo arrivati alla diagnosi della malattia, lui mi ha detto: “Ricordati una cosa, a me, scusa se te lo dico, la vostra vita normale non interessa, perché la mia non è stata una vita normale. questa è una vita che vale. La vostra, scusate, no”. Sembra una boutade, detta da qualcuno che non sapeva che due giorni dopo sarebbe morto (e non lo sapevamo neanche noi).
F: Lui lo diceva: “Io sono di un altro pianeta”
P: Ecco, io lo dicevo che era un alieno. Come ha raccontato Flavia Pennetta, lui ha scelto di uscire di scena come avrebbe sempre sottoscritto per una vita intera. Federico ha avuto una vita meravigliosa e penso a quando era in Ecuador durante il colpo di stato, o quando era in Perù e ha preso l’ultimo volo disponibile prima che chiudessero l’aeroporto per il terremoto, o quando era nel Bronx alle 2 di notte. Lui non avrebbe mai scambiato la propria vita con quella di nessun altro. La diagnosi è arrivata il mercoledì ed è morto il sabato.
F: Io ho ancora scritto nella testa il messaggio suo “io e il babbo ti dobbiamo parlare”. Mi ricordo, dopo avermelo detto, di aver fatto un giro in centro camminando con quella sensazione di impotenza che ti dici “e ora, che si fa?”. Non dipende da me, non dipende da loro. Qui siamo in mano a che cosa? Ed è una sensazione bruttissima. Incontri la gente, la saluti, e non ti serve a niente rispetto a ciò che vorresti ti desse.
P: Io penso che noi abbiamo impiegato qualche mese per renderci conto della realtà che ci è successa in sei giorni, perché ci è morto sotto gli occhi.
F: Io sono stata a prendere Federico a casa sua per portarlo dal dottor Benci che lo avrebbe ricoverato subito. A Federico veniva da vomitare, aveva un linfonodo grosso come una palla da tennis, l’hanno ricoverato in Ematologia, poi io non l’ho più visto. Il sabato mattina chiamo per sapere come stava e mia madre mi dice che si è sentito male ed è in rianimazione. Io, mio fratello, non l’ho rivisto più vivo. L’ho visto attaccato alle macchine ma Federico era già morto venerdì notte. Ci siamo dovuti adattare alla situazione. Siamo passati dall’essere la famiglia del tennista che gira il mondo, fa casino, arriva qui e butta giù tutto, mi lascia la roba da lavare, i calzini puzzolenti, alla famiglia di Federico Luzzi che è morto in una settimana.
P: È una notizia che ha scosso il mondo sportivo come una bomba. Noi abbiamo scoperto il lunedì, nel duomo di Arezzo, quanto era noto e amato perché c’è stata gente che è venuta da ogni angolo del pianeta. Lui era sempre in giro per il mondo e mi diceva di andare a vederlo, almeno al Roland Garros, a Wimbledon. Io però avevo una mamma anziana, e così ho fatto il mio grande slam personale dopo la morte di Federico proprio in memoria sua, compreso il Master per andare a vedere dove lui giocava e mi diceva “vieni”. Il fatto che dopo 8 anni e 9 mesi, in questo momento, ci siano almeno due-tre posti dove c’è il “torneo Fedelux” ad Orvieto e il “circuito Fedelux” in Alto Adige, dopo tanto tempo, è il segno di quanto amore ha dato questo ragazzo.
Paola, in psico-oncologica con genitori che hanno perso un figlio, o che sono sulla strada di perdere un figlio per il cancro, c’è un aspetto delicatissimo da conoscere, sul quale vorrei la tua personale opinione. Perdere un figlio squarcia nel punto più profondo della propria anima; per quanto il dolore dilani costantemente come una tortura della realtà, c’è una parte del genitore che non vuole comunque che qualcosa vada a colmare questo squarcio. Anche se poi ci possono essere situazioni che possono confortare, in altre zone dell’anima, questo squarcio resta eternamente per un genitore che ha perso un figlio, per quanto conforto poi possa comunque ricevere dal mondo e dalla presa di coscienza a posteriori di quanta vita il figlio ha saputo creare intorno a sél.
P: La prima cosa che mi viene in mente è che tu hai detto “non si vuole”. Io ti posso rispondere che si vorrebbe ma, secondo me, non si può. Io provo a dire una cosa che è un pochino grossa: come madre, siccome l’ho portato dentro, l’ho partorito e l’ho allattato credo, scusa se può essere una cosa un po’ presuntuosa, che il rapporto di una madre con un figlio sia diverso rispetto a quello del padre con il figlio. Lo dico pur non essendo una mamma-chioccia, tanto è vero che questo ragazzo l’ho mandato deliberatamente per il mondo a 13 anni e mezzo per provare a seguire questo sogno. A posteriori, visto che è morto a 28 anni, ringrazio veramente che la mia formazione mentale mi abbia impedito di dire “me lo tengo a casa, perché così me lo proteggo”. Se pensavo che il cordone ombelicale fosse stato tagliato 37 anni fa al momento del parto, adesso, che sono passati quasi 9 anni dalla sua morte, mi rendo conto che il cordone ombelicale non si taglia mai, perché nel momento in cui ti muore un figlio ti accorgi che non te l’hanno mai tagliato, perché quel cordone, quel qualcosa, rimane vivissimo. Dal momento nel quale io credo che la morte faccia parte della vita, che sia il rovescio della medaglia, io potrei anche voler continuare a vivere, non dimenticando perché non dimentichi mai, ma tornando alla normalità. Quindi non è che non vuoi. Io ho avuto l’aiuto di una psicanalista perché altrimenti non sarei sopravvissuta alle cose, ma me le sono chiarite e credo di essere pienamente in equilibrio. Però, è talmente innaturale questa forma di lutto che ti rimane un segno. Io ho seppellito prima mio padre, poi mia madre, poi mio fratello e poi mio figlio: le prime due sono accettabili, la terza un po’ meno, l’ultima no. Per cui, anche se vuoi, secondo me, non la superi mai. Qualcosa, per forza, rimane. Come un’ustione.
E se tu in questo momento potessi abbracciare attraverso la parola chi sta vivendo qualcosa che tu hai vissuto 8 anni e 9 mesi fa? A distanza di questo tempo, cosa pensi di ciò che hai scoperto ti avrebbe aiutata nel momento in cui in pochi giorni tuo figlio è passato da Federico Luzzi che gira il mondo per i tornei, a Federico Luzzi che ha affrontato un’incredibile storia di leucemia che ha scosso il mondo intero e che è morto?
P: Vediamo se pensiamo la stessa cosa. Dillo tu, Francesca
F: Se ripenso a quei giorni, siamo noi che abbiamo consolato le persone nella camera mortuaria.
P: Nessuno ti può dir niente e non vorresti niente da nessuno. Sei talmente concentrato su te che te lo devi trovare dentro su quello che tu hai già. E solamente dopo tu puoi fare qualcosa per gli altri. In quel momento nessuno può far qualcosa per te. Ed è per questo che credo nel lavoro che tu fai e in questo progetto: devi preparare la gente prima. Quella di Federico è una dipartita anomala, perché sono pochi i casi che si svolgono in un così breve lasso di tempo. Chi si trova in quella situazione, non esiste parola, abbraccio, gesto che possa darti qualcosa. Per chi la vive, meglio che il lasso di tempo nel quale avviene il tutto sia breve.
F: Noi siamo andate avanti, all’inizio come se fosse un film, non capivamo. Io avevo due bambini piccoli, facevo la mamma su di una nuvoletta, con il cervello spento, ma lo facevo perché dovevo farlo. Mi preoccupavo per Anna, che aveva tre anni, ma la mia psicoterapeuta mi disse che avrei dovuto preoccuparmi più di Alessandro che stavo ancora allattando, e che ha succhiato tutta la mia sofferenza. Se dovessi rivedermi dall’alto, mi rivedo rigida, nella camera mortuaria. Mi ricordo tutta le gente che veniva, che salutava e, vedendola, scappava quasi un sorriso rivedendo una persona che si incontrava da tanto tempo. Nella non-lucidità, eravamo noi quelli più lucidi.
P: Credo che nella nostra situazione, nessuno ti può dir niente. Forse in altre situazioni dove c’è un tempo di adattamento, l’aiuto è possibile.
F: Noi non abbiamo avuto il tempo di vivere la malattia
P: Per questo motivo apprezziamo il lavoro che stai facendo, come prevenzione, come educazione mentale, razionale ed emotiva. Quando torno a casa io dico a Francesca che domani potrei finire sotto un camion e lo dico perché credo che sia anche giusto dirlo. Quella volta a Fiumicino, aspettando il volo per l’India, non feci il controllo perché mi sono detta che avevo tutto nella testa e se mi fosse successo qualcosa che cosa sarebbe successo alla Fedelux? Allora ho comprato un block-notes e ho scritto 19 pagine a mano con i codici, i fornitori, gli eventi. Questo delirio di onnipotenza avrebbe potuto scomparire in un attimo. Ecco il perché di quelle pagine. La vita sembra un automatismo. Una volta un giornalista chiese a Patty Pravo cosa stesse facendo in quel momento. Lei rispose che stava portando avanti la sua vita e non era un lavoro da poco. Io rimasi folgorata da questa risposta perché noi pensiamo che vivere sia automatico invece vivere è un lavoro continuo, costante, di scelte impercettibili ogni minuto. Ogni scelta che si fa è un lavoro sommerso. Con l’automatismo pensi di essere immortale poi un giorno pensi che, se ti succedesse qualcosa, non tutto si troverebbe nel posto giusto. La morte di Federico è comparabile ad avere avuto un frontale con un Tir, perché lui ha perso conoscenza, è entrato in rianimazione e poi è morto. Questa è la storia di Federico, ma se posso dire un’ultima cosa io voglio ringraziare te e Atleti al tuo fianco, perché gli state dando un passaggio; grazie a questo ancora una volta la sua storia e la sua vita possono essere raccontate nella loro unicità, nel racconto della vita di un Alieno.