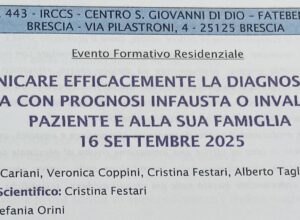La lotta al cancro e il mondo dello sport si incontrano nel progetto Atleti al tuo fianco, con l’obiettivo di raccontare la quotidianità di chi affronta un tumore e di far sentire loro la vicinanza degli sportivi professionisti. Il progetto è patrocinato da aRenBì Onlus ed è curato dal dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo bresciano con diploma d’alta formazione in psiconcologia. Entra a far parte di questa squadra Giamba Venditti, rugbista italiano, tre quarti ala della Nazionale Azzurra. Il tema affrontato in questa intervista è circostante alle situazioni e alle emozioni legate al cancro della prostata.
Giamba benvenuto negli Atleti al tuo fianco. La tua esperienza nel rugby sarà lo spunto aiutare chi legge a conoscere meglio alcuni aspetti legati al tumore alla prostata e alle emozioni delle persone che lo combattono. La prima domanda ti permette di presentarti: raccontaci chi sei costruendoci la tua storia come preferisci, per farci capire come sia nato il legame tra il rugby e Giamba Venditti.
Io ho iniziato a giocare a rugby quando avevo 9 anni e non conoscevo nulla di questo sport; quando leggo di tanti sportivi famosi che arrivano per caso a fare quello in cui eccellono, mi fa sempre ridere perché anche io ci sono arrivato per caso. Uno dei miei migliori amici, classici amici del cuore, si era appena iscritto; un giorno eravamo a giocare e lui si era dimenticato di avere allenamento, così mi ha invitato ad accompagnarlo. Io ero uno di quei classici bambini che non si spegnevano mai, per cui andare a correre a casa sua o andare a correre in un campo, era uguale. Gli istruttori che erano lì quel giorno sono stati molto molto bravi perché mi hanno detto: “Guarda, quando ti passano la palla, prendila e cerca di non farti prendere da nessuno e valla a poggiare sulla linea di fondo.” Bellissimo, per uno come me, bellissimo! “E quando non ce l’hai, vai a prendere il ragazzo con la palla, buttalo per terra, rubagli la palla e fai la stessa cosa di prima”. Così è iniziata la mia storia sul campo da rugby, un po’ caotica perché prendevo tutti, le davo a tutti, anche a quelli della mia squadra, perché non avevo ben capito, quindi quando non avevo la palla andavo lì, me la prendevo e andavo a segnare. Fatto sta che mi ha appassionato così tanto che quando mio papà è venuto a prendermi in questo primo allenamento, io sono corso da lui tutto contento, gli ho iniziato a tirare la maglietta, ancora me lo ricordo, e gli faccio “papà, papà, papà, ho deciso che sport voglio fare, ho deciso che voglio giocare a rugby, dimmi tutto quello che devo fare per arrivare in nazionale”. Così, eccomi qua.
Entriamo ora nel tema del tumore alla prostata parlando di una figura fondamentale nella vita di ogni uomo: l’urologo. Una professionalità che per certi aspetti corrisponde al ginecologo nella storia della vita di una donna, ma culturalmente c’è un’attitudine maggiore nell’educazione madre-figlia all’individuazione di una figura medica di riferimento e di dialogo. Il genere maschile è meno a proprio agio nel riconoscere nell’urologo una risorsa fondamentale per la salute del sistema urinario e riproduttivo. La prostata è un organo esclusivamente maschile e, come ogni altro organo del corpo umano, richiede prevenzione e controllo, affinché la sua interazione con il sistema urinario, endocrino e riproduttivo garantisca una qualità della vita soddisfacente. Il primo passo per parlare di prostata è il riconoscimento nella propria vita della figura a cui poter fare le domande, con la quale vincere quello strano disagio di parlare di un organo che coinvolga l’apparato riproduttore: l’urologo, appunto. Parlaci di rugby e delle tue figure di riferimento: ti è mai capitato di avere un allenatore nelle cui mani ti sei affidato con riluttanza ma che poi si è rivelato determinante per la tua crescita?
Gli allenatori a cui mi sono affezionato subito sono rimasti importanti per me: a pelle evidentemente funzionava la chimica fra di noi, e quindi andava tutto bene. Ma se devo pensare ad una persona importante e determinante nella mia crescita, vorrei parlare di un giocatore, che è stato capitano della nazionale a lungo, si chiama Marco Bortolami. Lui è molto più grande di me, per cui quando io ero piccolino e guardavo le partite, lui era già capitano della Nazionale, però ci siamo incrociati all’inizio della mia carriera con la sua parte conclusiva, giocando qualche anno insieme, sia in Nazionale, sia al club. Adesso lui fa l’allenatore e il nostro rapporto è sempre stato molto bello, il classico del “giocatore a fine carriera e giocatore agli esordi”, lui aveva tanta voglia di dare e io avevo tanta voglia di ricevere. All’inizio io avevo una percezione completamente diversa da lui, perché lo vedevo, diciamo, molto spigoloso. Non scorderò mai il primo allenamento che abbiamo fatto insieme: era un pre-stagione a Viadana, classico mezzo giro di campo, un po’ di stretching e a un certo punto il preparatore atletico dice “dai adesso fate dieci affondi per gamba”. Io ero alla mia prima esperienza tra i grandi, allora mi sono messo veramente a contarli dieci per gamba, invece tanti andavano un po’ a caso. Non dimenticherò mai come Marco Bortolami a un certo punto a uno dei ragazzi che avevano finito subito abbia detto: “tu non ne hai fatti 10, fanne 10”. Mi si è gelato il sangue, ho pensato “oddio per fortuna che li ho fatti, aiuto, con lui devo stare molto attento”. Lo conoscevo da tifoso, ma adesso si stava condividendo lo spogliatoio quindi era veramente un’altra cosa, provavo timore vero. Invece poi si è rivelata una persona super influente su di me, perché con lui sono stato a lungo a parlare di qualsiasi cosa, dal rugby a tutt’altro. Lui era stato capitano degli Aironi, capitano delle Zebre, la squadra in cui lui ha finito la carriera, capitano in nazionale, capitano quando è andato a giocare in Francia, capitano quando è andato a giocare in Inghilterra, quindi una persona abituata a guidare. Era uno di quelli pronti a dare ogni consiglio e delle volte, all’inizio della carriera, mi diceva tante cose che lì per lì non capivo. Io con i miei sacrifici e la mia determinazione ho vissuto la mia di carriera, ma ogni step importante mi veniva magari in mente qualcosa e dicevo “ecco cosa intendeva Marco quando diceva che…” e così via. Alla fine, stile profezia, tutto quello che mi aveva detto si era poi avverato, nei miei confronti e poi nei confronti di tante altre cose. Per questo nella mia vita è stata ed è una persona molto influente.
Continuiamo questa strada del dialogo che hai aperto tu. I dubbi e le incomprensioni alimentano la paura: per questo è fondamentale che il mondo medico generi chiarezza già a partire dal linguaggio necessario per spiegare le diagnosi. Molte persone confondono il tumore prostatico e l’iperplasia prostatica benigna, due patologie della prostata diverse. Essendo un organo sensibile agli ormoni, con l’avanzare dell’età anche la prostata può andare incontro a modificazioni strutturali, spesso legate ad un aumento del numero cellulare che ne accresce le dimensioni: questa è l’iperplasia prostatica benigna. Non è il cancro prostatico, però tantissime volte purtroppo viene percepita come tale, si cade nell’equivoco e si rischia di vivere delle paure amplificate: per questo c’è bisogno di adatta spiegazione perché le persone possano comprendere quello che sta loro accadendo. Prevenzione e controlli sono fondamentali in entrambi i casi per occuparsene con la dovuta professionalità e precisione. Torniamo al rugby: tu hai fatto una parte della tua carriera all’estero, ti sei mai trovato a dover fare i conti con timori maggiorati dalla difficoltà di comunicazione o comprensione di un’altra lingua rispetto ad un tuo infortunio o alle tue condizioni di salute?
All’inizio della mia carriera io mi consideravo un professionista esclusivamente del rugby, quindi mi dedicavo al campo solamente: io davo tutto per giocare bene, gli altri professionisti intorno a me, fisioterapista, medico e così via, si occupavano del loro ambito di responsabilità. Quando mi sono trasferito a giocare in Inghilterra ho capito che qualcosa in questa visione dovesse cambiare già dalla firma del contratto, quando mi hanno veramente analizzato in ogni minimo dettaglio del mio corpo. Mi sono infatti accorto di quanto invece noi giocatori avessimo un ruolo molto attivo nella nostra cura, per necessità di ricostruzione individuale della storia dell’infortunio e del problema. Fortunatamente l’inglese l’ho sempre parlato molto bene, ma a livello tecnico per quanto riguarda infortuni e malattie mi ha salvato aver fatto il liceo classico. Capivo alcune parole dalle radici latine e greche, soprattutto nei dialoghi molto pratici che facevo con il fisioterapista. Quando non sapevo qualche parola, la dicevo in latino: mi viene anche da sorridere pensandoci, ma così me la sono cavata. La comunicazione è importante, la sensazione di non comprendere, ma anche di non spiegarsi, quando si ha un problema diventa un aggravamento del problema stesso e delle conseguenti emozioni che si provano.
Quando l’apparato riproduttore maschile ha una malattia, ci sono ancora presenze di una cultura che faccia pensare che ci si debba per qualche motivo vergognare. In alcune persone sono ancora radicati dei modelli di falsa virilità, completamente fuori dalla condizione reale, per i quali si creda che il maschio debba sempre presentarsi nella sessualità come prestante e che, in qualche modo, una malattia affossi la valutazione di questo parametro, già di suo fuori dalla realtà. Il corpo umano si può ammalare, a volte all’esofago, a volte al seno, a volte alla prostata. È importante occuparsene per garantirsi una qualità della vita soddisfacente, anche riducendo modelli stereotipati e irreali di sessualità. Anche il rugby viene spesso associato ad un modello universale di virilità: hai mai percepito in qualche modo questa correlazione nella tua vita e cosa ne pensi a riguardo?
A me piace pensare che questa finta vetrata dei maschi alfa e della virilità stia un po’ crollando. Chiaramente il rugbista è ancora molto associato a una figura del genere, lo stereotipo del rugbista sempre in giro in infradito, che non ha paura di niente, io la vedo un po’ crollare. Quando noi siamo i primi a dire “ok, non è così!”, allora ecco che la percezione anche degli altri nei nostri confronti si modifica, ma cambia solo quando si è davvero modificata la tua stessa idea a riguardo. Io ho fatto tutta una carriera dove sono stato molto sciocco, da questo punto di vista: avevo paura a dire quando avevo male, avevo paura a dire quando qualcosa mi spaventava, e quindi ecco che ho giocato tantissime partite quando non ero assolutamente in condizioni di giocare, a volte fisicamente a volte mentalmente. In realtà poi questo si traduce in performance non adeguate, quindi di conseguenza tu non giochi bene, quindi per te stesso stai facendo un danno, perché quando fai prestazioni non di livello, il primo a soffrirne sei chiaramente tu. E poi, la metto allo stesso livello di importanza, la squadra: se non sei nelle condizioni di giocare bene, fai un danno anche ai tuoi compagni. Quindi ogni tanto alzare la mano e dire: “Ok, io non mi sento bene” è un gesto di correttezza, verso te e verso chi ti sta vicino: all’inizio della mia carriera non succedeva mai, anzi, veniva tacciato di debolezza chi lo facesse. Invece adesso c’è tutta un’altra dinamica, tanti ragazzi stanno molto più attenti, per quello che dico che sta cambiando. Il rugby è stato da sempre molto sensibile al tumore prostatico, proprio perché sintomo di un attacco ad una fittizia virilità: così come è visto il rugby, sport apposta per il maschio forte, il cancro alla prostata era visto come proprio l’opposto. Quindi questa è stata una malattia che il rugby ha preso proprio sottobraccio, perché da tantissimi anni sta cercando di sensibilizzare in tutto il mondo alla prevenzione, alla visita e al dialogo con l’urologo. Questa visione del superuomo fa credere una persona singola in grado di fare qualsiasi cosa, ma la natura nostra è tutt’altro, è quella di stare insieme, di chiedere aiuto quando non ce la si fa. Per cui questo sembra un tabù rotto ma in realtà stiamo tornando alla normalità, cioè stiamo tornando alla dimensione in cui un uomo, se ha un problema, può tranquillamente dirlo che resta uomo, anzi.
Quando alcune cellule tumorali si trovano in un organo diverso da quello dal quale sono originate, si parla di metastasi. Ci sono tumori particolarmente portati a fare metastasi, il tumore alla prostata è uno di questi e predilige alcune sedi di destinazione, come ad esempio il tessuto osseo. Questo dialogo con te ci porta a mettere in evidenza due aspetti importanti, spesso fraintesi. Il primo: una volta la metastasi era una sentenza per il paziente, una condanna a morte, adesso non è più così. Sebbene la guarigione di un tumore metastatico sia ancora molta difficile, esiste il concetto della cronicizzazione, cioè fermare la crescita e l’espansione del tumore tenendo sotto controllo l’impatto che le metastasi hanno nella qualità della vita quotidiana. Il secondo: quando si parla di medico palliatore, non si intende colui che si occupa della morte non dolorosa, ma la figura necessaria a gestire l’impatto del dolore nella vita quotidiana con un tumore. Le cure palliative non si pongono l’obiettivo della guarigione, ma sono determinanti per la qualità della vita anche in fase precoce di malattia, per questo può capitare di doversi relazionare con un medico palliatore senza che ciò significhi essere vicini alla conclusione della propria vita. Con lui si pongono obiettivi di rilevanza quotidiana, non destinati alla vittoria finale sul tumore. Parliamo di Rugby: spesso tifando la Nazionale Italiana nelle competizioni maggiori ci si trova a pensare che a fine partita non arriverà una vittoria. Eppure abbiamo spesso visto pagine di storia scritte in queste sfide difficili, come ad esempio la vittoria contro il Sudafrica a cui tu hai preso parte. Raccontaci quanto è importante riuscire a dare il massimo, anche nelle situazioni in cui pensi che non vincerai, per raggiungere la possibilità di vincere una sfida per molti ritenuta impossibile.
Una domanda stupenda, parto per rispondere da una frase bellissima di Henry Ford: “che tu pensi di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione”. In qualche modo quello che noi pensiamo accade non per uno strano potere della mente, ma semplicemente perché si innescano una serie di reazioni a seconda delle nostre credenze. La partita che abbiamo vinto a novembre 2016 contro il Sudafrica ancora adesso resta forse il più grande risultato della Nazionale. Io ho avuto il piacere di giocare e di segnare una meta in quella partita; giustamente ognuno ricorda il 20-18 di quel giorno a Firenze ma la cosa importante, che chiaramente nessun tifoso si ricorda, era successa 7 giorni prima quando perdemmo 68 a 10 contro la Nuova Zelanda. Sconfitte del genere ti possono trascinare in una depressione sportiva palpabile, il tutto sempre inquadrato in una dimensione dello sport,: perdere 68-10 è una botta enorme, non la dimentichi presto. Purtroppo nella mia carriera sono forse di più le partite che ho perso che quelle che ho vinto, ma qui la retorica aiuta molto, perché è molto inflazionata la frase del “s’impara dalle sconfitte”: è vera, se tu la rendi vera, se davvero tu riesci a tirar fuori quello che poi riesci a comprendere, da una sconfitta. Allora sì, quella ti aiuta, anzi è fondamentale: solo in quel caso ben vengano le sconfitte, ben vengano i fallimenti che fanno parte di questo processo di crescita, per avvicinarsi all’obiettivo. Quando abbiamo perso con la Nuova Zelanda ci siamo raggruppati e posso assicurare che noi ragazzi abbiamo giocato bene, la Nuova Zelanda di qualche anno fa, del 2016, era ingiocabile, quindi molte squadre probabilmente si sarebbero buttate giù e avrebbero perso anche contro il Sudafrica. Io dentro di me dicevo: “abbiamo giocato bene, se giochiamo così con il Sudafrica li possiamo battere perché il Sudafrica non è la Nuova Zelanda, però ci dobbiamo credere.” La settimana è stata bella, c’è stato questo tipo di partecipazione e coesione da parte di tutti. Le vittorie si costruiscono non soltanto nella partita del sabato: lì ti ritrovi dentro uno spogliatoio insieme ad altri compagni e tutti chiaramente vogliono vincere la partita, ma c’è un muro che ti separa dall’altra squadra che, guarda un po’, vuole vincere la stessa partita tanto quanto te. Quindi non è la motivazione del chi vuole vincere di più a fare la differenza per vincere una gara, perché quella, se massima, è uguale. La vera chiave per costruire la vittoria è poterti rispondere sì a certe domande: lunedì, cioè a sei giorni dalla partita, sei stato disposto a fare tutto quello che dovevi per vincere la partita? Martedì, avevi lo stesso tipo di fuoco da farti fare tutto quello che dovevi per provare a metterti nelle condizioni migliori per vincere la partita? E così via. Le grandi vittorie arrivano presto o tardi, ma semplicemente perché non hai mai smesso di lavorare soprattutto quando eri lontano dall’obiettivo, perché tu non puoi sapere quando quella vittoria arriverà. Noi non possiamo sapere quando, però quello che è in nostro potere è crederci ogni volta e lavorarci ogni volta di più, per metterci nelle condizioni di poter prima o poi godere della vittoria enorme.
Chiudiamo con una domanda dedicata alla coppia. Un tumore è sempre una malattia familiare, perché coinvolge non solo chi lo colpisce ma anche chi gli sta accanto. Condividere le emozioni più intime vissute nel corso di un tumore prostatico con la propria metà è segno di maturità: parlarsi per capirsi reciprocamente. Portare l’attenzione sulle emozioni non vuol dire togliere l’attenzione all’aspetto clinico, entrambe le situazioni sono importanti e costituiscono il percorso della coppia e della famiglia coinvolte in una diagnosi di cancro, si possono portare avanti in contemporanea, anche con l’aiuto dell’equipe medica. Tu hai un percorso di studi invidiabile e hai raggiunto il traguardo della laurea: hai mai temuto che portare attenzione ad un aspetto tra studi e percorso sportivo potesse limitare e penalizzare l’altro?
Penso che la prima grossa direzione da questo punto di vista me l’abbiano data i miei genitori, perché quando avevo 15 anni sono uscito di casa per andare a giocare a rugby; mi sono trasferito da solo, quindi la mia famiglia, i miei amici, la mia scuola, tutti i miei punti di riferimento erano rimasti in Abruzzo. A me chiaramente l’opportunità di poter giocare a livello un po’ più alto piaceva tantissimo quindi, anche lì, così come a 9 anni mi sono aggrappato alle maglie dei miei genitori chiedendo di mandarmi. Loro sono stati molto coraggiosi, sono stati di grande sostegno in questa mia scelta: lo dico da genitore di tre figli, il più grande ha 10 anni e l’idea che tra cinque anni possa venire a tirarmi la maglietta e dire “papà, io voglio giocare a basket, però per fare questo devo andare in America, posso andare?” inizierei a piangere oggi. Eppure i miei genitori hanno avuto quel coraggio determinante per trasformare tutta la mia vita, la mia realizzazione personale e sportiva. Quindi lì metto la prima pietra. Qualche anno dopo, verso i 17 anni, mi sono trasferito nell’accademia che la federazione aveva creato per i migliori 30 ragazzi d’Italia: io ero stato selezionato e ho dovuto cambiare di nuovo scuola. I miei genitori però mi hanno detto: “ok, vai, vivi il tuo sogno, ma gli esami torni a farli alla tua scuola a Roma, quindi studia.” Quindi già nella mia testa non sono mai state due cose distinte, dovevo fare quello e dovevo fare quell’altro. Per cui quando sono arrivato a 21 anni e ho esordito in nazionale, ero già papà e mi ero già iscritto all’università, perché nella mia testa tutto poteva andare insieme. Chiaro che c’è bisogno di organizzazione e forza di volontà, perché soprattutto nei momenti pre-esame era complicato, perché comunque io alla mia carriera sportiva ci tenevo tanto e non volevo togliere spazio all’allenamento. Amo tantissimo i miei figli, quindi amavo enormemente stare con Leonardo quando era piccolo, quindi non volevo togliere del tempo neanche a lui. Mi svegliavo la mattina molto presto, studiavo quando erano tutti a letto; poi si svegliavano, portavo i bambini a scuola, andavo a fare gli allenamenti, tornavo, tornavano loro, giocavamo nel pomeriggio, tutto bello. Cena, bambini a letto, mia moglie a letto e io aprivo i libri: non volevo togliere tempo a nessuno. Però questo mi ha aiutato tanto, perché non penso che né il rugby abbia limitato la mia carriera universitaria e formativa, né tanto meno l’università e lo studio abbiamo limitato il rugby. Anzi, io penso che aver passato così tanto tempo sui libri abbia sicuramente migliorato la mia percezione di atleta, perché io penso che una persona migliore diventi anche uno sportivo migliore. Per essere tale c’è bisogno di continua formazione, ovvero studio, piccole curiosità quotidiane, tutte quelle domande che uno si può porre per cercare le risposte: io la vedo così. E stessa cosa, il mio professionismo sportivo mi ha facilitato tantissimo nella mia vita fuori dal campo: tutto quel senso di partecipazione, sostegno, disciplina, organizzazione, vita all’interno di uno spogliatoio, sono tutte cose che nella vita fuori dal campo mi hanno aiutato in maniera determinante.