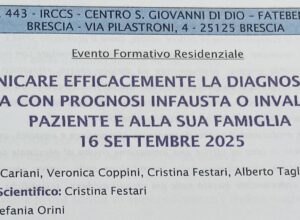Si può dialogare di momenti di vita sportiva per offrire spunti di riflessione sulle difficoltà di chi combatte contro il cancro? Questa è la scommessa che offre il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con DAF in psico-oncologia e patrocinato dall’associazione Arenbì Onlus. Prende parte a questa iniziativa Leonardo De Araujo, ex calciatore ed allenatore, campione del mondo con la maglia del Brasile ad USA ’94.
Ciao Leonardo, benvenuto nel progetto “Atleti al tuo fianco”. Oggi parleremo insieme di lotta contro il cancro e di alcuni aspetti della quotidianità che vivono le persone e le famiglie che affrontano un tumore maligno. Per fare questo prenderemo spunto da situazioni della tua carriera sportiva, delle quali ci racconterai i tuoi personali aspetti emotivi. Per avvicinarci a questi obiettivi, partiamo da una domanda preliminare che ci dia modo di conoscerti meglio in ciò che non riguarda il mondo calcistico: raccontaci qualcosa di più di te, chi è Leonardo De Araujo nella sua quotidianità?
Ciao a tutti, sono Leonardo ma mi piace farmi chiamare Leo, ho 48 anni compiuti e la mia vita è molto diversa adesso rispetto a poco tempo fa. Gran parte delle mie giornate è infatti riempita dal mio ruolo di papà: da qualche anno infatti ho dei ritmi di lavoro molto diversi rispetto a quando facevo il giocatore o l’allenatore e questo mi consente di vivere appieno i tempi e i compiti di genitore. Ho cinque figli: tre sono grandi, vivono in Brasile e nonostante la distanza ho un bellissimo rapporto con loro. Quando erano piccoli non ho potuto vivere la quotidianità con loro, perché per la mia attività calcistica ero sempre distante: basti pensare che il mio primogenito è nato all’inizio dei mondiali di calcio del ’94 e io ho potuto abbracciarlo solo al termine degli stessi. Qui in Italia ho due figli piccoli e un po’ perché svolgo un lavoro diverso, un po’ perché a 48 anni non dai alle situazioni lo stesso peso di quando ne hai 24, oggi la mia quotidianità è molto legata alla famiglia. Sicuramente ha contribuito anche un’esperienza vissuta con mia madre, che tre anni fa si è ammalata di una forma di tumore che ha richiesto un intervento molto invasivo e delicato, per il quale i medici non erano inizialmente ottimisti. Oggi la mia mamma sta bene, ha una qualità della vita soddisfacente e più o meno mensilmente riesco ad andarla a trovare in Brasile. Questa esperienza con lei mi ha fatto pensare a molti aspetti della vita ai quali prima sinceramente davo meno peso e importanza, quindi il posto di dominio che la famiglia ha preso nella mia vita mi rende oggi felice.
In Italia vi sono 360.000 nuove diagnosi di cancro ogni anno, circa 1000 al giorno; tuttavia quasi il 40% di questi tumori sarebbe evitabile seguendo stili di vita corretti. È fondamentale educare la popolazione alla conoscenza di questi stili di vita, ma al tempo stesso è molto importante capire che incontrare nella propria vita il cancro non è una colpa. Bisogna lavorare per togliere il senso di colpa in chi crede di essere stato in qualche modo causa della propria diagnosi maligna, perché è un sentimento che complica notevolmente la qualità della vita mentre si affrontano le terapie. Durante i mondiali nel 1994, tu con il Brasile hai vissuto una situazione delicata: nel corso del primo tempo contro gli Stati Uniti, padroni di casa, sei stato espulso per un colpo involontario molto forte dato ad un avversario durante un’azione sul risultato di 0-0. Hai mai dovuto gestire il senso di colpa per aver esposto il Brasile a rischio eliminazione dal mondiale a causa di un gesto compiuto da te?
Questa domanda mi emoziona molto, perché devo ammettere che in alcun modo io riesco a sentire dentro di me quel mondiale vinto come lo sentono i miei compagni di squadra, anche perché dopo quell’espulsione io non ho più giocato nella competizione. Io non ho mai smesso di ripetere che quel gesto non è stato volontario, perché io l’ho vissuta da dentro e lo posso assicurare; guardando le immagini, se non l’avessi vissuta, penserei il contrario pure io. Entrano quindi in gioco tantissime emozioni convulse, non solo relative al rischio di far uscire dai mondiali il Brasile, ma anche essere segnato eternamente come il colpevole di un gesto inguardabile, che ha causato una frattura cranica e le convulsioni a Tab Ramos, il mio avversario: basti pensare che il giorno successivo sulla prima pagina del New York Times c’era la mia foto con la didascalia “The most violent man in the world”, l’uomo più violento del mondo. A prescindere della mia involontarietà, io ero comunque realmente colpevole, perché eravamo all’ultimo minuto del primo tempo, stavo giocando molto bene e proprio io, in un secondo, lasciavo i miei compagni con un uomo in meno per il resto della gara. Fu fischiata la fine del primo tempo e mi ritrovai negli spogliatoi con tutta la squadra, sentivo dentro di me una sensazione di frustrazione e di paralisi emotiva, in questi enormi spogliatoi statunitensi stavo seduto sulla panchina a testa bassa. Poco prima che i miei compagni rientrassero in campo, mi si avvicina il mio carissimo compagno Bebeto, che in quel mondiale faceva coppia d’attacco con Romario. Mi si siede vicino e mi dice: “Leo, tranquillo: faccio un gol io e vinciamo noi”. Quella partita finì 1-0 per il Brasile con gol di Bebeto. E con questo non voglio sottolineare l’aspetto profetico del suo comportamento, ma il fatto che intuì come mi potessi sentire, che capì la mia angoscia data dal senso di colpa. Semplicemente, Bebeto in altre parole mi disse: guarda che l’obiettivo resta la vittoria, possiamo vincere comunque e puoi contare su di me, non importa se abbiamo rischiato di più per colpa tua, la vittoria non è un merito ma una conquista, ci arriviamo comunque. Quei mondiali poi li vincemmo noi in finale ai rigori proprio contro l’Italia: io non sento dentro di me quella vittoria come i miei compagni, perché i miei personali mondiali finirono nell’istante dell’espulsione, ma quella vittoria salvò anche me dalle ripercussioni che avrebbe potuto avere quell’episodio sulla mia carriera e sulla mia vita.
Ogni essere umano è legato agli elementi che nella storia e nella quotidianità lo identificano rispetto a qualsiasi altra persona. Una persona che affronta un tumore sa che in questo percorso incontra molti tentativi di spersonalizzazione, di annullamento cioè della propria personalità: la perdita dei capelli, la modifica di alcuni tratti somatici, l’allontanamento dalla propria casa, la privazione delle abitudini maturate nel tempo, in determinati momenti delle terapie tutto questo si può presentare come un nemico che cerca di annullare l’individualità della persona. È bene lavorare sulle risorse proprie del paziente non sfiorate dalla malattia per mantenere alto il valore dell’identificazione della propria unica personalità. Nel calcio, i sistemi di gioco sono caratterizzati da ruoli predefiniti codificati da cifre come 4-4-2 o 3-5-2; quando sei stato allenatore del Milan hai abbattuto questa consuetudine creando un sistema chiamato 4-2-fantasia. Quanto questa tua scelta è stata dettata dalla volontà di valorizzare le individualità di grandissimi campioni, slegandole da concetti generici dettati da codici numerici?
La storia di questa scelta è lunga e bisogna sempre cercare di arrivare alle radici per comprendere fino in fondo tutto l’albero. Io sono Brasiliano, vengo da un paese di matrice e cultura tattica meno rigorosa rispetto al calcio italiano. Arrivavo in questo Milan formato da campioni straordinari che però avevano già vinto molto nella loro carriera: siamo infatti nel 2009, si è appena conclusa l’era di Ancelotti, si è ritirato pochi mesi prima Paolo Maldini e viene venduto Kakà. Era lampante che fosse un passaggio delicato anche nella storia della società, era infatti in corso un evidente cambiamento. Vengo quindi chiamato, alla mia prima esperienza da allenatore, a guidare questa squadra e tutti questi elementi di storia non potevano secondo me essere trascurati dalle mie decisioni. Nella zona offensiva chiamata fantasia vi erano poi effettivamente dei grandissimi campioni: Ronaldinho, in una fase forse calante della sua carriera ma pur sempre un giocatore incredibile, Inzaghi, un giovanissimo Pato forse nel suo momento migliore, Seedorf, Beckham, Borriello che si rivelò utilissimo e giocò molto spesso. Non dimentichiamo poi che tra i due di centrocampo, uno era sempre Andrea Pirlo, per cui quel sistema avrebbe potuto chiamarsi anche 4-1-fantasia. Secondo me andava creato qualcosa che potesse in qualche modo toccare il loro entusiasmo: da entusiasti avrebbero fatto cose da grandi campioni quali senza dubbio erano. Io ho solo cercato di mettere giocatori di maggiore qualità insieme e di ritagliare loro uno spazio di libertà, che si potesse trasformare in responsabilità nella loro volontà di renderla concretizzabile. Rompere uno schema numerico e creare qualcosa di nuovo è stata l’idea per entusiasmarli e renderli responsabili della libertà e autonomia che non avrebbero avuto con un qualsiasi sistema scritto da cifre.
Per questa decisione, quanto ha influito la tua carriera da calciatore nel corso della quale ti sei dovuto adattare a ricoprire molti ruoli all’interno del campo? Hai mai vissuto la sensazione di non vederti valorizzato nelle tue personali qualità per la priorità al sistema di gioco?
Sinceramente io non mi sono mai sentito un fuoriclasse, per cui non ho mai avuto questa preoccupazione. Avevo un altro tipo di presunzione, pensavo di essere quello che capiva meglio le cose. Ho sempre avuto giocatori straordinari al mio fianco in tutto il corso della carriera, a partire da Zico, Junior, Bebeto al Flamengo per arrivare a George Weah e Paolo Maldini al Milan e in nazionale con Ronaldo e Romario, solo per citare esempi a caso di ogni squadra. Con questi presupposti, pur riconoscendo di avere anche un peso tecnico importante, dovevo mettere a frutto la capacità di capire meglio le cose. La mia duttilità quindi era figlia della volontà di fare quel che fosse più necessario perché la squadra funzionasse, per me è sempre stato così. Quindi non mi sono mai sentito in alcun modo degradato attraverso dei cambi di ruolo, perché se sotto il profilo tecnico la mia operatività poteva essere differente in base al compito che mi veniva assegnato, sapevo che così ero utilissimo nella mia propensione a capire bene le situazioni.
L’oncologia sta facendo progressi, anno dopo anno: attualmente la sopravvivenza ad una diagnosi di cancro è intorno al 70%. Tuttavia la costante ricerca di un prolungamento della vita o della guarigione non deve in alcun modo distogliere le forze anche nei confronti di coloro che ricevono da subito una diagnosi di un tumore ad uno stadio avanzato o che affrontano un cancro in fase terminale. Concentrarsi sui successi, su chi ha vinto la battaglia, è importante per trasmettere il messaggio che di tumore si può guarire, ma la battaglia contro il cancro non si perde morendo, ma non curando adeguatamente la dignità della vita, in qualsiasi condizioni essa si presenti. Il diritto alla vita è importante tanto quanto il diritto ad una morte curata, seguita e in condizioni di dignità elevata. Tu sei stato giocatore nel Brasile di Ronaldo a Francia ’98, allenatore del Milan nella stagione dopo il ciclo di vittorie di Ancelotti, allenatore dell’Inter nella stagione successiva al ciclo di vittorie di Mourinho. Nello sport, esiste secondo te il diritto di non vincere quando sei il più forte? Può il Brasile avere riconosciuto il diritto di perdere il mondiale del ’98 contro la Francia?
A livello sportivo, la risposta a questa tua domanda è no. E infatti, quella sconfitta non è stata mai accettata. Ma anche quando ho allenato al Milan, non avendo vinto trofei sono andato via come “poca roba”. Ancor più emblematico secondo me è il caso dell’Inter, dove con la mia squadra deteniamo il record di 12 vittorie consecutive in casa, ma pur recuperando da -13 punti dalla vetta abbiamo chiuso al secondo posto. Anche la vittoria della coppa Italia, in un contesto nel quale l’Inter veniva dall’aver sollevato la Champions League la stagione precedente, non è bastata per ritenere la stagione un successo. Nel calcio, non è sufficiente fare bene se poi non vinci. Certo, l’ambiente in cui ti esprimi conta tantissimo, ma parlando di casi come il Milan, l’Inter, il Brasile ma anche il PSG, se fai bene ma non vinci non è sufficiente, anzi non è una cosa accettabile. È una differenza sottile, ma non si può parlare di diritto a non vincere, semplicemente è una sconfitta. E la differenza tra una vittoria e una sconfitta ha una valenza enorme non solo per la società con la quale le ottieni, ma anche per te stesso. Però in tutto questo, c’è qualcosa che è sì inattaccabile dalle sconfitte, ed è il percorso condiviso con i compagni. A Francia ’98 abbiamo perso, ma tutto quel percorso condiviso per arrivare in finale, le emozioni, le paure, resterà tutto eternamente negli sguardi di intesa e nella relazione tra noi Brasiliani che l’abbiamo costruito. Stessa cosa con i giocatori del Milan 4-2-fantasia, stessa cosa con i ragazzi dell’Inter delle 12 vittorie consecutive a S.Siro. Il percorso condiviso riesce ad essere più forte anche delle sconfitte: la complicità, con o senza vittoria, è eterna. Ma nel calcio ai massimi livelli, il secondo posto è nulla.
Quando una persona sta affrontando una malattia, vengono spesso utilizzate le statistiche per fornire esempio di ciò che lo attende: espressioni come “ci sono delle possibilità al 75%” o “nessuno è mai sopravvissuto più di quattro anni con questa stadiazione” vengono talvolta usate a questo scopo. Tuttavia, ciò che a volte si sottovaluta, è che la storia delle statistiche è l’insieme dei singoli casi già vissuti da altre persone: ciò significa che non riguardano necessariamente il paziente in questione, che ha una storia ancora da scrivere e, forse, mai scritta prima uguale. Tu da allenatore hai portato il Milan a vincere contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu per la prima volta nella sua storia, 2-3 con gol di Pirlo e doppietta di Pato: quando hai preparato la gara, lo hai fatto con la convinzione che esistesse la possibilità di concretizzare un evento mai successo precedentemente?
Era un momento particolare della stagione, venivamo da una vittoria con la Roma in rimonta a San Siro dopo essere andati al riposo in svantaggio; l’ingresso di Seedorf come centrocampista aveva dato una svolta sia alla gara sia alla convinzione della squadra. Andammo quindi a Madrid a giocare con il Real, dove appunto il Milan non aveva mai vinto, con lo stesso sistema di gioco che aveva fatto svoltare la partita con la Roma. Incominciò la sfida e dopo dieci minuti Dida perse il pallone su una comoda presa e Raul segnò un gol per il Real; soffrimmo per tutto il primo tempo e ci trovammo negli spogliatoi sotto di una rete. Il rischio era che il gruppo percepisse come azzardata la mia scelta di giocare in quel modo a Madrid; in realtà resi ancora più offensiva la situazione, avanzando Seedorf ulteriormente nei giocatori d’attacco e lasciando solo Pirlo e Ambrosini a centrocampo. Tranquillizzai i ragazzi dicendo loro che si dovesse puntare ad avere il pallone nella zona di campo in cui noi presentavamo nei i secondi 45′ Pato, Inzaghi, Ronaldinho e appunto Clarence Seedorf. Ad inizio ripresa ribaltammo il risultato con un gol di Pirlo e uno di Pato, il Real trovò il 2-2 a su un tiro da fuori area, noi vincemmo con un gol di Pato all’ultimo minuto su assist di Seedorf. Risultato finale 2-3, Santiago Bernabeu espugnato dal Milan per la prima volta nella storia. Ora, non posso dire che avessi previsto questo, in alcun modo. Anzi, quando Dida commise l’errore dopo dieci minuti, dentro di me ebbi paura che potessimo andare a casa con una goleada a nostro carico. Però quando sei l’allenatore del Milan, non puoi mai pensare che ci possa essere una partita che non puoi vincere a priori. Certo, fino ad allora non ci era mai riuscito, ma resti comunque il Milan, con grandi campioni. Era poi una stagione particolare, con una classifica non brillante, che concedeva qualche azzardo in più. Mi ricordo che l’elemento determinante per me fu Adriano Galliani che durante il volo verso Madrid, in un colloquio a due, mi tranquillizzò facendomi capire che la società era con me, di fare le mie scelte in tranquillità perché se avevano scelto me era perché si fidavano del mio modo di vedere il calcio. “Se vuoi farli giocare tutti, falli giocare tutti” mi disse. Io mi sentii sereno nel trasmettere questa identità ai ragazzi nell’intervallo, loro si sentirono convinti nel percorrere quella strada. Un’impresa non si improvvisa, ci sono sicuramente moltissimi elementi e dettagli da curare per poterla compiere, ma al tempo stesso non si può prevedere con totale certezza un esito solo focalizzandosi sulle vicende precedenti: una storia ancora da scrivere può diventare l’eccezione di un caso mai verificatosi.
Grazie Leo, ora fai parte anche della nostra squadra, quella degli “Atleti al tuo fianco”.