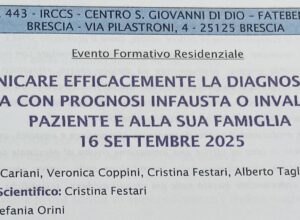Raccontarsi come sportivi per aiutare chi sta affrontando il cancro: questo è in sintesi il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con diploma d’alta formazione in psico-oncologia, e patrocinato da Arenbì Onlus. Gli atleti rispondono a domande mirate per raccontare momenti particolari della propria carriera e offrire spunti di ispirazione e reazione per chi si trova a vivere la quotidianità affrontando un tumore. Entra a far parte di questa squadra di atleti Massimo Agostini, attaccante degli anni 80 e 90 di Milan, Napoli, Cesena e molte altre squadre di serie A.
Massimo, la tua esperienza calcistica con Atleti al tuo fianco diventa spunto per approfondire alcune sfumature della vita quotidiana mentre si combatte contro il cancro. Per iniziare, raccontaci qualcosa della tua personale evoluzione una volta conclusa la carriera di calciatore: chi è Massimo Agostini da quando non indossa più gli scarpini su un manto verde?
Sono rimasto la solita persona legata alla famiglia, alle persone, alla Romagna e al calcio: sono padre di una figlia e sono marito, ho calcato per tanti anni tanti prati verdi e tanti stadi e a fine carriera sono rimasto in questo ambito, perché sento nel mio sangue questo ambiente di lavoro. Sono diventato così allenatore della nazionale Under21 Sanmarinese, poi da allenatore della primavera del Cesena sono passato alla Serie A femminile, per poi rivestire il ruolo di allenatore/giocatore ancora a San Marino. Da lì ho dato il via al mio legame con il beach soccer come giocatore prima e allenatore della Nazionale Italiana, dando così questa direzione alla mia vita, di uomo che ama il calcio e sa fare calcio, cercando di condire il tutto con l’ingrediente della passione.
Entriamo nel primo tema riguardante l’oncologia e ci concentriamo sul significato del tempo, diverso a seconda dell’ambito a cui si riferisca. Il tempo è un nemico se sei in attesa di un referto, un alleato nei momenti condivisi intensamente, una carezza se riesci ad avere un sonno soddisfacente, una tortura quando viene impiegato per riflettere su dubbi che non trovano soluzione. Alcune volte alle persone che affrontano un tumore è importante chiedere come percepiscano il tempo, perché le sfumature da conoscere sono molte e profondamente personali. Nella tua storia di calciatore, la capacità di rubare il tempo ai difensori tuoi avversari è stata una costante di forza: come riuscivi ad avere una lettura anticipata delle situazioni rispetto a tutti gli altri sul campo?
Nel ruolo in cui ho giocato per più di vent’anni se non avessi appreso a mettere in relazione lo spazio e il tempo, avrei avuto una carriera senza dubbio ad un livello più basso e forse nessuno mi avrebbe mai soprannominato “Condor”, a cui sono molto legato. Alcune volte le situazioni decisive di una partita di calcio si giocano sulla differenza di pochi decimi di secondo: l’occhio e la mente sono la postazione di comando che devono dire al resto del corpo quando e come agire. Se sei bravo a rubare la frazione di secondo al difensore, quel pallone che sta per arrivare si potrà chiamare gol un attimo dopo. Sicuramente in tutto questo l’allenamento è un concetto importante, ancor più se qualche bravo allenatore riesce a insegnarti qualche personale strategia esecutiva, però credo che la parte preponderante della situazione sia gestita da un intuito innato, per il quale io dal primo giorno in cui sono sceso sul campo da calcio ho sentito dentro di me l’identità dell’attaccante. È davvero grazie al tempismo che nella mia carriera sono riuscito a fare più di 150 gol tra Serie A, B e C; mi spiace solo che tutto questo non sia bastato a farmi vivere un’esperienza con la maglia della Nazionale.
Sentirsi in mani affidabili per una persona che deve curare un tumore è un’aspetto importante per affrontare con fiducia i momenti di incertezza clinica, quando i miglioramenti attesi non si presentano come da speranze e previsioni. Ma la affidabilità è una qualità che si costruisce nel tempo, non solo offrendo un alto livello professionale medico e paramedico, ma anche valorizzando il rapporto umano con paziente e famiglia nelle situazioni di ogni giorno, perché da curare vi è una persona prima che una malattia. Tu ad inizio anni ’90 hai militato nella migliore squadra del mondo in quel momento, il Milan di Arrigo Sacchi: tu che l’hai vissuta da dentro, nell’elevato livello calcistico vi era spazio anche per un’attenzione alla crescita individuale e alle emozioni singole?
Per me è stata la punta più alta nella mia carriera, effettivamente nella squadra più forte al mondo in quel momento, una gratificazione importante a fianco di tantissimi campioni, i più forti di tutti quasi in ogni ruolo. Questo ha fatto sì che di spazio per giocare ce ne fosse poco, consapevolmente. In questo ambiente però ho avuto la netta sensazione che la maturazione di un giocatore venisse portata alle sue massime potenzialità, circondati da una professionalità importante. Era il top dei top come squadra e come ambiente, era impensabile non accettare di andare a rivestire anche il ruolo di semplice alternativa in una rosa del genere. Noi più giovani o che provenivamo da realtà più piccole sapevamo di dover lavorare con serietà e impegno per farci trovare pronti nelle eventualità in cui fossimo necessari, mettendo l’allenatore nelle condizioni di potersi fidare scegliendoti. Quindi lo spazio per il miglioramento personale era vincolato alle necessità di rendimento dell’individuo per l’insieme, perché in queste squadre contavano i trofei sollevati a fine stagione. Lo spazio per la delusione personale non ci può essere: sai che devi lavorare senza demoralizzarti se non sei chiamato a scendere in campo, il tuo ruolo è offrire la massima condizione in caso di chiamata e questo ti spinge a lavorare sempre al massimo, migliorando molto individualmente. Per me è stata un’esperienza molto importante.
Nel corso di un ricovero, ogni persona che si trovi in ospedale aspetta trepidante il momento nel quale potrà fare ritorno a casa. La presenza costante della propria famiglia, ma anche dettagli sottovalutati come un animale domestico o il proprio letto, possono cambiare la qualità delle giornate per chi sta affrontando un tumore. È importante che, quando sappiamo di persone ricoverate, riusciamo a mandare messaggi di presenza e vicinanza, perché lontani da casa tutto diventa più difficile. Nella tua carriera hai spesso fatto ritorno a Cesena: possiamo dire che da calciatore è stata una società nella quale ti sei sentito a casa?
Io sono partito a 15 anni da Rimini e sono entrato nel settore giovanile del Cesena, mi hanno preso da una società del Riminese e fino ai 22 anni ho fatto la Berretti, la primavera e la serie B, per poi passare alla Roma in uno scambio di mercato con Rizzitelli. Ogni volta che sono stato in una squadra nella quale ho sentito di non aver espresso al meglio il Massimo Agostini che ritenevo di poter offrire, io ho scelto di tornare a Cesena. Nell’annata giallorossa con Liedholm in panchina, avevamo due modi molto diversi di intendere il mio modo di giocare e mi sono ritrovato a fare la fascia. A fine anno, pur con un contratto in corso, ho voluto con tutte le mie forze tornare a Cesena per rimettermi in gioco e lì ho ricostruito l’attaccante che poi è approdato al Milan. Anche dopo l’esperienza al Napoli ho fatto questo nuovo passaggio in bianconero, io al Manuzzi mio sono sempre sentito a casa e ogni volta ho avuto la sensazione con quella maglia che mi stessi esprimendo al meglio, al massimo delle mie possibilità.
Una famiglia che affronta le cure, gli esami di controllo, i follow up di un percorso oncologico, spesso si sposta dal proprio paese o città di origine in altre città o regioni, fermandosi alcune volte per poche ore, altre per molte settimane. È importante stimolare le famiglie, in base alle condizioni di salute, a provare a dedicare un’ora in più a qualcosa nelle città slegato dagli aspetti clinici: un museo, due passi in un centro storico possono migliorare lo stato d’animo e la relazione con una città, che è qualcosa di più di un ospedale. Tu sei stato a giocare in tantissime città, come Ravenna, Parma, Napoli, Ancona e molte altre ancora: sei riuscito ad instaurare un rapporto con la città e la gente del posto, andando oltre campi d’allenamento e stadio?
Io sono un romagnolo purosangue che si è trovato a conoscere tante realtà diverse anche lontano da casa. Ho girato e vissuto le città anche con la mia famiglia e ho potuto conoscere l’anima dei luoghi in cui sono stato perché ho legato con tante persone. Per me anche solo un semplice incontro per strada, con la richiesta di autografi o di una fotografia, era l’occasione per conoscere qualcuno, fare due chiacchiere o farsi dare un consiglio sulla città. In questo modo penso di aver non solo indossato i colori delle squadre, ma di aver vissuto e scambiato con le piazze e le persone che per quei colori si emozionano. Anche la mia famiglia con me ha bellissimi ricordi, ma alcune volte mi sono spostato da solo se mi trovavo vicino a casa, come ad esempio ad Ancona: in quel caso sono stato io a sentire un po’ di nostalgia dai miei affetti, ma quando potevo tornavo subito ad abbracciarli. Nella mia vita la famiglia è stata fondamentale, forse anche per questo ho sempre amato poi scambiare e legare con le persone che incontravo: alla fine sono tutti legami che danno valore alla vita.