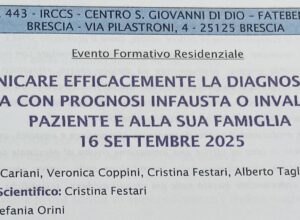Si può dialogare di momenti di vita sportiva per offrire spunti di riflessione sulle difficoltà di chi combatte contro il cancro? Questa è la scommessa che offre il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con DAF in psico-oncologia, e patrocinato dall’associazione Arenbì Onlus. Fa parte di questa speciale squadra Riccardo Pittis, giocatore italiano di basket, 118 presenze con la Nazionale, vincitore di 7 scudetti con le maglie di Milano e Treviso, leggenda della pallacanestro italiana.
Riccardo, benvenuto in Atleti al tuo fianco: il basket e la tua storia sportiva saranno spunto per raccontare alcuni aspetti della vita quotidiana delle persone che stanno combattendo contro un tumore. Per avvicinarci a questo obiettivo, partiamo raccontando qualcosa della tua personale quotidianità: come si trasforma la vita di tutti i giorni di un atleta quando smette di essere un giocatore, dopo più di vent’anni di carriera?
Il giorno in cui ho smesso di giocare a basket, la mia quotidianità è cambiata in modo radicale. La vita dell’atleta è segnata da tempi scanditi, ripetitivi: sveglia, allenamento, pranzo, riposo, allenamento, cena (puoi uscire una sera se l’allenamento del giorno te lo permette). Passare da questo stato così abitudinario, ad una situazione dove non ci sono più regole, può risultare particolarmente difficoltoso, addirittura traumatico. Inizialmente non vivi bene questo cambiamento poiché ti viene a mancare una parte di te che è stata fondamentale a livello fisico ed emotivo per molti anni, ma anche tutto il complesso di soddisfazioni personali, l’adrenalina. Insomma, in altre parole, ti trovi spaesato. Passato questo periodo, quando finalmente ti rimetti in moto e inizi ad avere altri e nuovi stimoli che sostituiscano la pallacanestro dandoti nuove soddisfazioni
Chi sta affrontando un tumore, racconta che costruire un rapporto familiare di fiducia e confidenza con lo staff clinico che lo prende in carico in ospedale, migliora la sua qualità della vita. Anche una struttura curata nei particolari fa la propria parte per attenuare le difficoltà nella ciclicità dei ricoveri: in qualche modo, si deve offrire al paziente ricoverato un ambiente che possa per lui diventare familiare facendolo sentire accolto. Nella tua storia sportiva, tu hai vestito solamente due maglie di club: quella dell’Olimpia Milano e quella della Benetton Treviso. Per riuscire a concretizzare la carriera da sogno che hai avuto, quanto è stato importante essere stato parte di un ambiente che, stagione dopo stagione, diventasse per te sempre più familiare?
Direi che, su una scala da 1 a 10, l’importanza che ha rivestito per me è quantificabile a 11. Io sono cresciuto personalmente e cestisticamente a Milano, dalle giovanili fino a diventare capitano della prima squadra. All’apice di questa crescita sportiva, da un giorno con l’altro, mi sono trasferito a Treviso. Ritrovarmi in un ambiente ed in una città che non conoscevo assolutamente, è stato molto difficoltoso. E’ venuto a mancare il fattore della familiarità e ciò è andato ad influire moltissimo sulle mie prestazioni. Il mio anno peggiore è stato, infatti, il primo in cui ho giocato alla Benetton Treviso, dopo il trasferimento. Da quel momento, anno dopo anno, mi sono inserito in quell’ambiente e fino a ricreare una familiarità i cui risultati si vedevano in campo. Aver ricreato quella fiducia e quel legame con l’ambiente e con la città ha fatto sì che oggi, io a Treviso abbia deciso di viverci.
Guardando al tuo percorso con la Nazionale, ci sono delle domande che vorrei porti. Quando una persona si trova ad affrontare un percorso costituito da tante tappe, se nella proiezione della durata, la sua mente somma le difficoltà, arriva alla percezione che potrebbe non avere risorse a sufficienza per superare il tutto. La psiconcologia aiuta a focalizzare i singoli obiettivi tappa per tappa, raggiungendoli mettendo a frutto i propri mezzi fino in fondo. Nei campionati Europei del 1991 e del 1997, con la Nazionale Italiana hai incontrato in semifinale, rispettivamente, la Spagna e la Russia, due giganti del basket europeo dell’epoca. Vorrei che tu mi descrivessi come tu hai vissuto l’avvicinamento a questi incontri, come tu hai potuto portare il tuo contributo per sconfiggere due avversari inizialmente insormontabili.
Provo a fare un esercizio di recupero di ricordi che oramai iniziano ad essere datati. Queste due squadre andavano affrontate con una fisiologica ed umana emozione, chiamiamola anche semplicemente paura. Ma è quella paura positiva che ti permette di essere molto concentrato, in adesione totale alla situazione. Oltre a ciò, bisogna dire che c’era un valido aspetto della consapevolezza delle nostre capacità, individuali e di squadra. Nel mio caso, non mancava poi mai una dose di carica agonistica sulla quale sapevo di poter e dover puntare. A quel punto, il resto spariva: si diventava solo un’insieme di emozioni positive pur nella difficoltà dell’obiettivo da raggiungere, ma la trance agonistica da noi innescata la faceva da padrone.
Una delle paure maggiori di chi ha nella propria vita affrontato un tumore è di incontrare una recidiva. Non è solo la paura di morire che spaventa: dover affrontare tappe di difficoltà e sofferenza, per quanto già superate in passato, sconforta e la mente rischia di paralizzarsi in maniera totale. Avere un precedente contro un avversario, condiziona i nostri pensieri. Nei campionati europei di cui parlavamo prima, dopo le due semifinali, tu e i tuoi compagni vi siete trovati in finale in entrambi i casi la Jugoslavia, autentica corazzata degli anni ’90. Come vi siete avvicinati alla partita nel 1997, contro gli avversari che già nel 1991 vi avevano impedito di vincere la medaglia d’oro?
Ho un ricordo molto nitido del momento in cui, una volta superata la Russia in semifinale, ci siamo resi conto che avremmo di nuovo avuto di fronte la Jugoslavia. Noi avevamo la chiara sensazione che li avremmo battuti: per questo, quando siamo scesi in campo, abbiamo iniziato la partita senza timori reverenziali, un po’ con la faccia tosta, senza alcuna paura. Era stato un bellissimo Europeo, dove contro la Russia avevamo fatto un’impresa ribaltando una situazione difficilissima e proprio quella partita ci galvanizzò per la finale. È vero che quella finale poi la perdemmo, nuovamente. Ma fu un percorso: passo dopo passo, quanto avevamo compiuto servì alla squadra che, due anni dopo, vinse l’Europeo, con un’altra generazione di giocatori nella quale io non c’ero più. Non puoi sapere quando raccoglierai, ma se semini bene prima o poi i frutti arrivano: per noi arrivarono nel 1999.
La semina senza la garanzia dei tempi di raccolta è importante ma non è cosa facile. Tu con la Benetton Treviso hai vinto uno scudetto nel 2001 dopo due finali perse consecutivamente. Come vi siete avvicinati a quell’appuntamento, siete riusciti a tenere lontani i timori del traguardo irraggiungibile?
Credo di aver ereditato una particolare mentalità dalla mia esperienza milanese, lavorando con mostri sacri, talmente vincenti da essere capaci di ribaltare situazioni disperate, come ad esempio il ritorno di quel Tracer Milano-Aris Salonicco del 6 novembre 1986 dove da -31 si andò a vincere di 34). Questa stessa mentalità l’avevo anche con la finale persa con la Jugoslavia: non c’è stato un secondo nel quale credessi di non poter vincere. Mi sono fermato solo quando, la partita era effettivamente persa. Io e i miei compagni, entravamo in campo con la convinzione di vincere le partite, sempre, senza risentire minimamente delle sconfitte precedenti, che facevano parte di un percorso che avrebbe portato alla vittoria. Nello sport come nella vita, il percorso è fatto di grandi vittorie ma anche di brucianti sconfitte. Per quanti scudetti io abbia vinto, ho perso altrettante finali. E lo stesso vale per le Coppe Campioni. Essendo consapevoli, nella vita e nello sport, di avere momenti in cui si vince e momenti in cui si perde, si entra in campo comunque con la voglia e la determinazione di vincere. Una volta finita la partita andiamo a vedere quello che è successo. Io non ho mai giocato da sconfitto. Certo, sono stato sconfitto, ma non ho mai giocato da sconfitto.
Essere pronti alle sfide della vita è una chiave fondamentale nella psiconcologia; perfino chi guarisce da un tumore è atteso da nuove sfide: riorganizzarsi la vita, con le nuove opportunità e difficoltà che contemporaneamente un lungo percorso oncologico concluso comporta, non è per niente facile. Più si sottovaluta questo aspetto, e più si fatica ad essere concretamente orientati. Negli ultimi anni della tua carriera, tu hai dovuto riadattare il tuo gioco poiché un problema fisico alla mano destra ti ha portato a diventare mancino. Vorrei che tu ci raccontassi il momento in cui tu hai accettato questa tua sfida, mettendo in discussione decenni di certezze e di successi sportivi. Hai mai pensato di non riuscire a raggiungere questo obiettivo?
Quello è stato l’episodio al quale ho ricondotto tutti i miei interessi successivi. Per chiunque, diventare mancini è una cosa difficile, per uno sportivo lo è ancora di più. Per me era praticamente impossibile dato che la mia mano sinistra avrebbero potuto legarmela dietro la schiena che mi sarebbe stato indifferente: a livello razionale, questo cambiamento era quindi irrealizzabile. Ma nel momento in cui io ho accettato che questa mano destra io non riuscissi più ad utilizzarla come volevo, mi sono trovato davanti ad una Sliding door, a un bivio che avrebbe cambiato il mio futuro: smettere di giocare o trovare una soluzione. Non ho nemmeno preso in considerazione la prima opzione, ma permaneva la frustrazione di non poter giocare come sapevo per una ragione che non dipendeva da me. Ho deciso di trovare una soluzione e quando ho infine accettato questa situazione, ho vissuto un cambiamento che mi sorprese all’epoca e che mi stupisce ancora adesso. In allenamento, in una settimana, io ero diventato mancino. Tiravo da sei metri senza problemi con una mano che per una vita non avevo nemmeno ipotizzato di utilizzare. Questo ti fa capire che noi siamo molto meglio di quello che pensiamo di essere. Non ci fidiamo delle nostre capacità che possono essere immense, se solamente troviamo la voglia di rischiare ed il coraggio di provarci, anziché mantenerci nelle retrovie perché abbiamo paura che ci ridano dietro. Eliminato questo timore e mettendoci in gioco, ci si rende conto che siamo in grado di fare cose straordinarie, o meglio ancora, cose ordinarie ma celate dentro di noi. Dopo questo passaggio, io non ero più lo stesso giocatore di prima, ma il solo fatto di aver fatto qualcosa che reputavo impossibile, mi ha dato la forza di essere un cestista molto importante per la squadra, giocando una media di minuti a partita molto alta fino all’ultimo anno della mia carriera. Quando prendi coscienza della tua grandezza, ti rendi conto di poter essere in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche la più difficile, anche quella che la tua mente reputava impossibile.