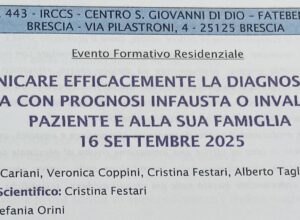La lotta al cancro e il mondo dello sport si incontrano nel progetto Atleti al tuo fianco, con l’obiettivo di raccontare la quotidianità di chi affronta un tumore e di far sentire loro la vicinanza degli sportivi professionisti. Il progetto è patrocinato da aRenBì Onlus ed è curato dal dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo bresciano con diploma d’alta formazione in psiconcologia. Entra a far parte di questa Gabriele Morelli, rugbista italiano e pilone del Calvisano, con cui si è laureato per quattro volte Campione d’Italia.
Ciao Gabriele, benvenuto nel progetto “Atleti al tuo fianco”. Oggi parleremo insieme di alcuni aspetti della quotidianità vissuta da persone e famiglie che affrontano un tumore maligno. Per fare questo, prenderemo spunto da situazioni della tua carriera sportiva, delle quali ci racconterai i tuoi personali aspetti emotivi. Partiamo da una domanda preliminare che ci dia modo di conoscerti meglio: raccontaci qualcosa di più su di te, chi è Gabriele Morelli nella sua quotidianità?
Ciao a tutti, sono Gabriele Morelli, ho trent’anni, sono nato a Montichiari e pratico rugby da quasi vent’anni. Ho iniziato a giocare per caso grazie a Gianfranco Ermolli, persona a me carissima, che aveva portato nella mia scuola il progetto rugby, facendo nascere in me la passione per questo sport.
Sono entrato in contatto con il rugby in un periodo non facile della mia vita familiare, perché ho perso mio padre a tredici anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica e posso dire che l’ambiente del rugby mi ha accolto come un figlio e mi ha cresciuto. Mi sento un privilegiato perché ho avuto la fortuna di girare tutto il mondo grazie a questo sport e sono sicuro che altrimenti non avrei mai avuto la possibilità di farlo.
Un giorno mi piacerebbe restare in questo ambiente, magari come allenatore, però nel frattempo non mi precludo altre strade: negli ultimi due anni e mezzo un amico mi ha coinvolto nella sua attività vinicola e questo mi ha fatto rinascere. Quindi al momento sto portando avanti parallelamente queste due attività che c’entrano poco o nulla l’una con l’altra. Amo seguire qualunque tipo di sport, a partire dal calcio: sono tifoso della Juventus e del Brescia, la squadra della mia città, che sta dando grandi soddisfazioni da quando Eugenio Corini, che so essere testimonial di Atleti al tuo fianco, ne è l’allenatore.
C’è un concetto del rugby che ha fatto breccia nell’immaginario collettivo: “arrivare alla meta”. Quando una persona riceve una diagnosi di cancro, la meta appare spesso lontana e anche poco individuabile nel tempo. Uno degli obiettivi della psiconcologia è allenare le persone a restare concentrate sul passo successivo: spesso infatti la meta è un tranello, perché non sai quando la vedrai. È più un luogo ideale, da non tenere troppo presente nella mente perché, se la invade, perdi il dominio sul momento contemporaneo.
Per un rugbista, qual è il momento in cui si inizia a pensare alla meta? In qualsiasi momento, in qualsiasi zona del campo o è una cosa che si materializza dopo una serie di passi singoli?
In una partita di rugby, non si pensa alla meta di per sé, ma a come vincere. Durante la gara ci sono varie fasi di gioco che ti portano all’obiettivo e tu devi superarle tutte; quando però ti avvicini fisicamente agli ultimi 20 metri, cominci a sentire che c’è qualcosa di diverso, si alza la tensione, la precisione, la concentrazione, per far sì che si scateni “l’istinto del killer” e tu colpisca lì. Non è facile: è chiaro che se, come nel mio caso, hai sempre giocato in una delle squadre migliori d’Italia, sei allenato a vincere e quindi, quando arriva il momento giusto, è molto più facile che questa concentrazione ci sia, però non è una cosa che tutti possono sentire. C’è chi l’ha nel sangue e sente la meta già 100 metri prima, mentre altri, come quelli che giocano nel mio ruolo di pilone tallonatore, non sono portati a farlo spesso: siamo più felici quando realizziamo un’azione che mette in condizione gli altri di poter segnare, perché tutto parte da come noi impostiamo il gioco.
Quando si segue una persona malata di cancro, bisogna sapere che i progressi nel tempo non sono mai un percorso costante. Tante volte ci sono dei piccoli passi in avanti, successivamente dei peggioramenti, poi dei miglioramenti e dopo ancora dei passi indietro. Questo genera incertezza, un nemico della mente in oncologia, perché ti fa sentire in balia degli eventi. È molto importante aiutare pazienti e familiari a capire che un passo in avanti non vuol dire per forza immediatezza della conclusione delle difficoltà, e uno indietro non significa annullamento della possibilità di guarire.
Nel rugby, se vuoi un aiuto da parte dei tuoi compagni per avanzare, devi passare la palla all’indietro: com’è sapere che puoi contare sul supporto degli altri giocatori solo se arretri il punto di possesso del pallone rispetto alla direzione verso cui devi andare?
Nel rugby passi la palla indietro quando vuoi mettere il compagno vicino a te nelle migliori condizioni, non quando tu sei in difficoltà: la passi per far sì che lui possa avanzare. Nel rugby si dice sempre “passo la palla e vado in sostegno”, perché dopo che l’hai passata non è finita, il tuo compito ora è garantire una protezione per il compagno e tante volte, quando arrivi vicino alla linea di meta e pensi in cuor tuo che ormai sia fatta, ti ritrovi davanti l’altra squadra che non accetta che tu faccia il punto, costringendoti a tornare indietro, con il rischio di perdere il pallone e commettere errori che possono favorire il club avversario. Proprio per questi motivi la coesione nel nostro sport è fondamentale, in ogni momento: in una squadra che punta a vincere il clima di fiducia deve essere totale. Nel corso non solo delle singole partite ma anche dei mesi, si susseguono veramente tanti alti e bassi, e solo tutti insieme si può riuscire a limitare i “bassi” e fare in modo che ci siano numerosi “alti”. Questo non è facile da costruire, perché far andare d’accordo cinque persone può essere facile, ma quando tu ne hai trentacinque, e con allenatori e staff arrivi a quaranta, non è facile creare un legame tale da permetterti di avere fiducia in tutte le persone.
Nella scala delle paure in oncologia, il rapporto con il dolore è addirittura più dominante rispetto al timore di morire: questo al di fuori spesso non viene colto. Bisogna aiutare le persone a conoscere e, passo dopo passo, dominare la paura di stare male, tenendo sotto controllo l’angoscia.
Se ci occupiamo dell’aspetto sportivo, il rugby da fuori viene visto come uno sport in cui prendi e dai tante botte. Quanto dolore affronta un giocatore di rugby nell’arco della sua carriera?
Questo in effetti è un punto un po’ delicato perché oggi a livello giovanile viene fatta molta prevenzione sugli infortuni e gli allenatori sono molto attenti a questo argomento: non mettono in campo un ragazzino se questi dice che ha male. Poi ci sono quelli che dicono “ho male ma gioco”, e dicendolo si sentono un po’ come degli eroi: non sono affatto sicuro questa sia una cosa positiva. Il dolore fa parte delle reazioni del corpo umano che dobbiamo conoscere, è sbagliato associare il concetto di “essere forti” ad “ignorare il dolore”. Nel mio caso, se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, forse qualche partita in meno la farei, dando più attenzione al dolore. È chiaro che quando vengono i tuoi compagni, lo staff, la dirigenza a chiederti se te la senti di giocare, provi in tutti i modi a entrare in campo, ma se farai male non sarà una giustificazione che stessi giocando con un problema: è stata una tua scelta. Certo, è evidente anche che se uno sportivo dovesse giocare solo quando è al cento per cento non giocherebbe mai, perché un minimo dolore, ce l’avrai sempre. Il problema è riuscire a convivere con questo: ci sono dei dolori che quando ormai arrivi a trent’anni conosci e sai che sono gestibili, mentre altri non lo sono.
Io, da parte mia, ho grande fiducia nello staff medico del Calvisano e se io dico “ho questo problema” e loro mi rispondono “ok il dolore che tu hai è presente, ma non ti può creare problemi ulteriori” allora io gioco, mentre se mi dicono che un mio sforzo può peggiorare la situazione, allora non gioco.
In questi aspetti è fondamentale rimettersi alla professionalità di chi ne sa più di noi.
Il dolore si esprime però non solo in maniera fisica: ci sono ferite profonde del nostro animo che spesso ci fanno sentire scaraventati in un abisso emotivo apparentemente irrecuperabile. Siamo tutti esseri umani: i campioni dello sport, i pazienti, i medici. Tutti uomini, e ci riguarda tutti. Come sei sceso in campo quando dentro di te vivevi dolori paralizzanti? Ci sono dolori emotivi che possono portarti a non giocare?
Nel mio caso, quando arrivo al campo d’allenamento, vedo i compagni e mi metto al lavoro, sono felice: in quelle due ore che trascorro lì, dimentico tutto il resto: questo fa sì che la mia testa sia libera e pensi solo ad allenarsi e, giocando, divertirsi. Appena smetto, la mia mente si accende e tornano i problemi di sempre.
La mia vita non è stata semplice, ho toccato con mano le difficoltà profonde di chi si ammala gravemente attraverso entrambi i miei genitori, ma questo non deve essere una scusante per scaricare le nostre difficoltà interiori su coloro che ci circondano. Ho avuto anche dei grandi doni dagli altri: la società Rugby Calvisano mi ha accolto, ancora ragazzino, come se fossi un figlio, mi ha sempre coccolato e fatto sentire importante. Nel mio percorso agonistico non ho mai lasciato che questi problemi prendessero il sopravvento: dico sempre che se vogliamo vincere dobbiamo cercare di isolare tutti i problemi. Questo è stata la cosa più difficile che ho fatto negli anni da capitano: riuscire ad estromettere i pensieri disturbanti e cercare di trasmettere entusiasmo agli altri ragazzi, facendo capire che quello che c’è fuori non è della squadra, e che la squadra può cercare di aiutarti a non pensare ai problemi fuori per creare un ambito che, isolato dal resto, sarà un cardine costante che migliorerà la tua vita nel suo insieme, che comprende anche i problemi.
Un errore che viene commesso con frequenza è pensare che, in un lungo percorso di diagnosi e terapia oncologica, si debba sempre essere forti. È fondamentale capire che ci sono giorni in cui ci si crede dei leoni e altri in cui ci si sente da buttare via. Tutto questo fa parte dell’essere semplicemente umani: non è segno di debolezza piangere o non avere voglia di fare nulla per qualche giorno, perché non è necessario essere degli eroi in ogni fase di malattia. Se prima di ricevere una diagnosi di cancro si veniva considerati “persone forti, inaffondabili”, è importante evolvere il pensiero e capire che la forza risiede parzialmente nella reazione ma molto di più nell’equilibrio. Nel Rugby, la Nazionale Italiana affronta spesso avversari più forti di lei: come ci si sente passare da giocatori allenati a vincere ad atleti che si sentono deboli di fronte ad un nuovo forte avversario?
Ho avuto la fortuna di fare parte di tutte le selezioni nazionali giovanili, fino ad arrivare ad un millimetro dalla Nazionale maggiore, che ho mancato più per pigrizia, una mia scarsa voglia di allenarmi; se mi fossi allenato a 22-23 anni come adesso che ne ho 30, probabilmente la mia carriera avrebbe fatto un ulteriore salto, di questo io ne sono cosciente. Quando tu indossi la maglia della Nazionale non devi pensare a te stesso, ma rappresenti tutti quei ragazzi che giocano a rugby, che sognano di poter giocare contro i migliori al mondo. Il problema è che appena mettiamo questa maglia si crea un complesso di inferiorità verso altre squadre; rispetto ad un Neozelandese o ad un Inglese, il giocatore italiano è meno preparato ad affrontare mentalmente le grandi sfide. La Nazionale maggiore ha vissuto un momento d’oro verso la metà degli anni 2000, intorno al 2005, perché tutti i giocatori italiani migliori giocavano all’estero: erano quindi seguiti da staff stranieri, che potevano contare sul supporto di uno psicologo, dieci preparatori, il video analyst e molte altre figure. In Italia, non c’è ancora sufficiente attenzione a queste professioni. Il ragionamento che si fa qui secondo me si avvicina all’idea “se compro un giocatore forte, vinco”, invece il ragionamento che si fa all’estero è più vicino a “cerchiamo di mettere il buon giocatore nelle migliori condizioni”. Questo si traduce nel porre il rugbista al centro di un servizio coordinato per la sua crescita, che proseguirà proprio grazie alle figure professionali che si occupano di lui.
Obesità e sedentarietà sono due fattori di rischio che aumentano la probabilità nella vita di andare incontro ad una diagnosi di cancro. Quindi alimentarsi meglio, senza rinunciare al piacere di mangiare, e fare movimento (come un’ora e mezza alla settimana di camminata) ti protegge dalla probabilità di andare un giorno incontro ad un tumore. Uno stereotipo consolidato afferma che i rugbisti debbano essere grossi, fisicamente pesanti, eppure c’è molta distanza fra l’obesità (che è il fattore di rischio) e l’abbondanza di massa muscolare.
Raccontaci come nell’adolescenza, nell’infanzia, si possano aiutare ragazzi e ragazze sovrappeso a mantenere la loro predisposizione ad avere tanta massa, trasformandola in massa muscolare, attraverso il rugby.
Secondo me tutto parte dalle scuole. Prendiamo ad esempio l’Inghilterra, dove i ragazzi a scuola fanno sport per molte ore: già così tu trasmetti al giovane il messaggio che si deve muovere. Lo studio deve essere collegato alla salute, perché più tu stai meglio, meglio riesci a studiare. Si è sempre detto che il rugby è uno sport per bruti, ed è anche vero, però ormai anche nel rugby quelli sovrappeso fanno fatica. Quando avevo vent’anni, anche con 10kg in più, non faticavo a correre, ma adesso ho dovuto adeguarmi e perdere peso. Ormai l’80% dei rugbisti segue un’alimentazione corretta: con una dieta equilibrata tu corri di più, rendi di più, duri di più. L’Italia deve crescere di mentalità, un aspetto non confinato al mondo del rugby ma generale: non c’è ancora, nel nostro Paese, la consapevolezza che una figura come il nutrizionista sia fondamentale per migliorare le proprie prestazioni. Questo sforzo nel perseguire un corretto rapporto con il cibo e con il corpo non può essere, a mio avviso, lasciato soltanto all’iniziativa personale, ci devono essere delle figure su cui fare affidamento e che aiutino in questo percorso. In questo modo, aiuteremo uomini a diventare atleti migliori, e giovani a scoprire attraverso lo sport un modo importante di fare prevenzione.