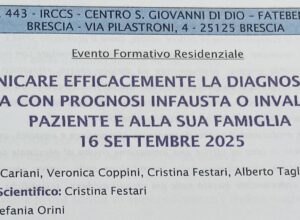Combattere un tumore e praticare lo sport ad alti livelli possono avere punti di connessione? La ricerca di un momento di riflessione profonda sulla vita e sulle difficoltà incontrate dalle persone che ogni giorno combattono la loro lotta contro il cancro è stato fin dalla sua origine l’obiettivo dichiarato del progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con DAF in psico-oncologia e patrocinato dall’associazione Arenbì Onlus. Il punto di partenza, un po’ insolito, per approfondire questo tema, è rappresentato dalle testimonianze di atleti delle più varie discipline che, con la loro carriera, hanno lasciato un segno nella storia dello sport nazionale ed internazionale. Attraverso la metafora dello sport, veniamo guidati per cogliere sfumature della quotidianità delle persone che combattono il cancro. Entra a far parte della famiglia di “Atleti al tuo fianco” Giacomo Galanda, ex cestista campione d’europa nel 1999 con la Nazionale Italiana di basket.
Ciao Giacomo, benvenuto nella squadra di Atleti al tuo fianco. La tua storia nel basket diventa spunto per conoscere alcuni aspetti della vita quotidiana delle persone che affrontano un tumore. Partiamo però dalla tua personale quotidianità: raccontaci qualcosa della tua vita ora che non sei più un giocatore di pallacanestro.
Nel percorso della mia carriera sportiva, le mie giornate sono state scandite da un ritmo abbastanza serrato, dettato da partite, raduni, play-off; nel momento in cui mi sono ritirato dal basket giocato la mia quotidianità è cambiata in modo radicale. Ho avuto la possibilità di scegliere tra diverse possibilità che mi si presentavano davanti, tra cui quella di assumere un ruolo dirigenziale: non è immediato, dopo 21 anni vissuti da atleta, adattarsi ad un cambio di ruolo tanto importante. Io ho cominciato questa mia seconda vita a Pistoia, diventando dirigente nel settore giovanile, per poi passare a fare il general manager presso un’altra società; al momento sono impegnato come consigliere federale, sempre nell’ambiente della pallacanestro, e mi occupo ormai da un po’ di tempo di organizzare camp ed eventi. Al di fuori del mondo del basket ricopro il ruolo di project manager presso un’azienda per la quale seguo tutte le iniziative di comunicazione. Oltre a questo, in collaborazione con la Lega, lavoro ad un programma televisivo.
Entriamo ora nei temi del basket che ci permettono di approfondire la vita in oncologia. Spesso chi affronta un cancro, e il relativo percorso di cura, si trova all’improvviso gli occhi delle persone addosso, anche a causa dei cambiamenti dell’aspetto fisico: si perdono i capelli, muta la forma dei tratti somatici, si perdono chili e accumuli di grasso sottocutaneo possono cambiare in parte la conformazione del viso. Ti senti improvvisamente osservato come se fossi un extraterrestre: non vivi più quell’invisibilità di cui, generalmente,godi nella vita quotidiana. Le persone intorno non fissano te, fissano ma una tua caratteristica, la tua malattia: questo può fare male. Tu Giacomo, sei un uomo alto 2,10 metri, che giocando ha acquistato la fama, quindi è probabile che da sempre il tuo corpo sia stato oggetto di osservazione e di commenti del tipo “come sei alto”, che precedevano addirittura la conoscenza della tua persona. Come si vive in un corpo che ti identifica prima ancora che tu possa presentarti?
È una domanda che nessuno mi aveva mai posto. Questo aspetto mi ha creato spesso disagio nella quotidianità, soprattutto da ragazzo, perché inevitabilmente ti distingue dagli altri e non ti fa certo passare inosservato. Da questo punto di vista però lo sport sicuramente mi ha aiutato: nella pallacanestro essere alti è un vantaggio e ciò mi ha permesso di costruire nel rettangolo di gioco una sorta di area protetta in cui potevo sentirmi “meno diverso”. Non è certo una tragedia ma, il giorno che ti alzi con la luna storta, una persona che ti dice cinque volte di fila “ma quanto sei alto” risulta fastidiosa! Tutti noi abbiamo delle peculiarità, dovremmo cercare di partire da queste per renderle dei nostri punti di forza. Ma se alcune volte dobbiamo aspettarci un comportamento migliore da chi ci sta intorno, spesso siamo noi i primi che possiamo migliorare, offrendo uno sguardo che non si fissi su alcune caratteristiche fisiche evidenti: questo sguardo non è sempre gradevole per chi lo riceve.
Una delle situazioni su cui la psiconcologia sociale si focalizza riguarda il messaggio che molto spesso arriva al paziente da parte di chi gli sta intorno: quel susseguirsi di “mi raccomando non mollare, fatti forza” rischia di essere distruttivo. Una mente impegnata a resistere senza mai mollare rischia di comportarsi come un motore che, non cambiando mai marcia, gira a regimi altissimi, salvo poi fondersi ad un certo punto, perché si è oltrepassato il limite. È opportuno garantire al malato i fisiologici momenti di sfogo, affinché possa fare pace con quella parte triste, arrabbiata, debole, che fa parte della vita umana, soprattutto in un percorso oncologico, e richiede i suoi spazi. Nel basket, rispetto ad altri sport, non ci sono ruoli che prevedano momenti di riposo, ma al tempo stesso non trascorrete 40 minuti costantemente in campo. Per un cestista, il passaggio dalla panchina è una pausa necessaria?
Quando sei in panchina mentalmente devi cercare di analizzare la partita anche meglio di chi sta in campo per poi farti trovare pronto, fresco e preparato ad entrare sul rettangolo di gioco: la tua prestazione deve essere al massimo per la funzionalità della squadra oltre che per la tua. Sono dinamiche difficili da analizzare facendo un discorso complessivo, dal momento che ci sono partite in cui giochi pochi minuti e altre in cui giochi 40-50 minuti. Anche nella pallavolo ci sono stop continui, ma nella pallacanestro le pause non sono determinate dalla fine dell’azione, in questo caso il gioco viene fermato dall’allenatore o dall’arbitro in situazioni particolari. Essere in panchina è un momento nel quale il corpo e la mente non sono portati alla massima intensità come sul campo, ma allo stesso tempo devono rimanere in grande attività, perché il ritorno in campo può essere improvviso e richiedere il tuo fondamentale contributo: anche se non sei in campo, resti comunque in partita.
Alcune persone, pazienti o familiari, a volte abbinano un senso di rassegnazione che si esprime nella frase “beh, ma se è destino che debba andare male…”: questa frase emerge in presenza di uno stato d’animo che tende al pessimismo, ma è fondamentale capire che, nonostante il destino si possa pensare scriva pagine importanti della nostra vita, senza dubbio anche noi abbiamo l’opportunità di scrivere parte della nostra esistenza. Quante volte nella tua carriera sportiva è successo di essere stato in grado di cambiare gli obiettivi predestinati, raggiungendo traguardi più alti rispetto alle previsioni di partenza?
La mia filosofia di gioco, ma forse prima ancora la mia filosofia di vita, dice che se non sei il primo a credere in te stesso, o quantomeno nella raggiungibilità dei tuoi obiettivi, sarà molto difficile che possa crederci qualcun altro. Se mi guardo indietro sicuramente la mia è stata una carriera fortunata, costellata di successi, ma non bisogna dimenticarsi che ci sono state anche sconfitte pesanti e annate più difficili. Resto convinto che noi abbiamo nelle mani la possibilità di indirizzare il nostro destino verso una migliore direzione, nella misura in cui riusciamo a migliorare noi stessi: lo sport ci insegna a dare il 100% in ogni situazione, questa resta in assoluto la condizione necessaria, anche se certamente non sempre sufficiente, per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Non ci sono bacchette magiche che possano farti vincere o meno, c’è il lavoro di squadra che, giorno dopo giorno, ha la capacità di limare i difetti di un gruppo e di amplificarne i punti di forza.
Una parte sostanziale del lavoro in psiconcologia è mirato non soltanto ad un percorso verso la guarigione, ma soprattutto al raggiungimento della pace con il proprio percorso oncologico: quando si riceve una diagnosi di cancro l’istinto è di riguardare la propria vita fino a quel momento, analizzandone alcuni aspetti sotto una luce diversa. Fare pace con il proprio vissuto e con la propria vita è l’obiettivo principe della psiconcologia e permette di generare all’interno della propria mente un sostegno di pace anche nel dubbio, quando cioè non si può ancora conoscere l’esito che avrà la malattia nel suo sviluppo. Essere in pace non significa in alcun modo essere rassegnati, ma combattere con maggiore sintonia con la realtà. Un giocatore come te, quando si ferma a riguardare la sua carriera, vede una storia di successi eclatanti, di vittorie sfiorate, di sconfitte amare. Tu, Giacomo, dopo aver smesso di giocare, quanto ti sei sentito “in pace” rispetto alla tua carriera?
Devo riconoscere che per me il momento del distacco dal basket giocato non è stato particolarmente traumatico, l’ho vissuto in modo sereno, anche se ovviamente si è trattato di uno spartiacque importante e per certi aspetti “rivoluzionario”: tutti i punti di riferimento che, come atleta, hai avuto fino a quel momento vengono meno e sei costretto a reinventarti fuori dal rettangolo di gioco. Detto ciò, come ho già detto, mi ritengo molto fortunato. Oltre ai numerosi successi ottenuti sul campo, ho avuto il privilegio di giocare fino a quarant’anni, fungendo in un certo senso “da chioccia” per gli atleti più giovani; ho potuto giocare sempre in squadre competitive, ho scelto io quando smettere: queste non sono fortune che capitano a tutti gli atleti, di questo mi sento grato alla mia carriera e alla mia vita. Dovendo riassumere, per descrivere il modo in cui guardo oggi a quella che è stata la mia carriera, userei quindi con decisione la parola “gratitudine”, che ben si accosta al concetto di “pace” prima descritto e su cui consola sapere che una persona ammalata di cancro venga guidata, nella sua ricerca interiore, personale e familiare.