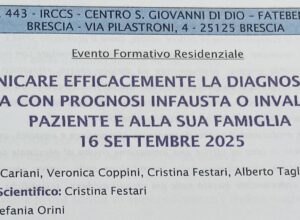Parlare di lotta al cancro conversando con sportivi professionisti delle loro difficoltà e abitudini quotidiane, permettendo loro di avvicinarsi e sostenere chi sta combattendo contro un tumore: questa è la scommessa che lancia il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo di Montichiari con DAF in psico-oncologia e patrocinato dalla associazione Arenbì Onlus. Oggi raccoglie a questa sfida Diego Nargiso, affermato allenatore di tennis ed ex tennista professionista, che nella sua carriera ha vinto il torneo di Wimbledon juniores e ha rappresentato la nazionale italiana in coppa Davis per 32 volte, scendendo in campo soprattutto come doppista, guidandola fino alla finale contro la Svezia nel 1998.
Benvenuto in questa sfida Diego, dialogando di tennis andremo a toccare temi che riguardano sia chi affronta la vita da sportivo professionista sia chi ogni giorno deve combattere contro un tumore maligno. Prima di tutto però, dacci la possibilità di conoscerti meglio come uomo: chi è Diego Nargiso in tutto ciò che non riguarda il tennis?
“Mi fa piacere questa domanda, perché mi dà possibilità di presentarmi meglio: mi considero un uomo normale, ho una famiglia con tre figli, mi piace fare sport, amo il cinema e la musica. Conosco tutti i cartoni animati perché li guardo spesso con i miei bimbi di 5 e 7 anni, anche questa credo sia una caratteristica in comune con molti genitori. Sono un uomo molto legato alle passioni, che hanno spesso avuto una parte importante nella mia vita: ho sempre messo il cuore prima ancora che la testa in qualsiasi cosa abbia fatto, e ancora oggi è così.”
La famiglia è un elemento molto importante in entrambe le situazioni di cui parliamo, sia quella sportiva sia quella oncologica. Quando una persona si ammala di cancro spesso infatti sente su di sé la responsabilità dello stato emotivo di chi le sta attorno: se sono malato e ho una giornata storta, anche i miei familiari ne percepiranno la negatività; non è facile convivere con questa sensazione di fronte a molte giornate difficili.
Tu da ragazzo hai vinto Wimbledon junior: hai mai sentito la responsabilità di dover raggiungere un obiettivo o una vittoria per compiacere le aspettative, figlie di quel risultato, di chi ti stava attorno?
“Dal mio punto di vista, non posso dire nella mia esperienza di legare le pressioni vissute al risultato di Wimbledon. Le pressioni secondo me un ragazzo le ha da quando cresce, indipendentemente da ciò che fa o ha fatto. Un ragazzo sente la pressione dei propri genitori semplicemente perché sapendo quanto amore queste persone ti hanno dato, loro si aspettano da te il massimo, sempre, anche se non è facile riuscire a dare il massimo in ogni occasione. Per me, ma non solo, ogni volta che sono andato in campo la mia preoccupazione è stata di far sentire fiera la mia famiglia.
La pressione familiare non la senti quindi per colpa dei genitori o di chi ti sta attorno secondo me, ma perché in quel momento in campo, o come suggerisci tu anche quando combatti in un letto di ospedale, tu vuoi in qualche modo ripagare tutti i sacrifici che sono stati fatti per te: non è un male dover convivere con questa sensazione, fa semplicemente parte di te, della tua storia e della tua vita. Tuttavia, avere giornate negative resta un diritto individuale, ma alcune volte quella che si manifesta come pressione nei confronti di chi ti circonda può essere trasformata in energia positiva per reagire alla difficoltà.”
Non sempre però per chi affronta e combatte il cancro c’è la possibilità di vivere le giornate circondati dai propri affetti: i ricoveri possono essere frequenti, e alcune volte anche in centri specializzati non vicini a casa, separando dal nucleo familiare. Tu, per diventare un tennista, hai dovuto affrontare l’allontanamento forzato dal tuo nucleo familiare?
“In qualche modo ho dovuto affrontare questa situazione, perché a poco più di sedici anni ero già professionista quindi mi sono dovuto prima trasferire a Roma e poi ho iniziato a girare il mondo per tornei, quindi le mie radici sono state effettivamente tagliate. Un tennista sta circa 42 settimane all’anno in giro per il mondo per cui devi imparare a convivere con la mancanza non solo delle persone per te più care, ma anche di abitudini quotidiane come la tua camera o il tuo cuscino. La mancanza che ho sentito di più è quella dei miei genitori, senza dubbio, anche perché non era semplice nel 1986 comunicare dall’Australia: ti sentivi veramente dall’altra parte del mondo, e non c’erano supporti tecnologici come ora che in qualche modo ti mantengono sempre in contatto diretto con chi ti vuole bene.”
Chi affronta una diagnosi di cancro, si deve mettere nelle mani di un’équipe sanitaria: un oncologo, un chirurgo, un medico diplomato in psico-oncologia e altre figure professionali costituiscono per lui la squadra di riferimento professionale. In certe situazioni in cui la situazione clinica si aggrava, si può insinuare nel paziente il dubbio che lo staff sanitario non stia facendo le scelte terapeutiche migliori: questo è un elemento che, se compare, diventa molto pericoloso per la serenità del paziente e della sua famiglia.
Tu Diego sei un allenatore, e quindi curi la crescita tennistica dei tuoi atleti: ti è mai capitato di vivere la messa in dubbio che stessi lavorando al meglio per l’evoluzione positiva del percorso di maturazione di un giocatore seguito da te?
“L’argomento che tocchi è un aspetto molto pertinente, con cui noi allenatori ci confrontiamo quotidianamente: il coach si deve mettere in dubbio tutti i giorni per poter offrire ai propri giocatori il miglior lavoro possibile. La mancata crescita di un giocatore, una sconfitta magari inaspettata mette sempre in dubbio le tue capacità e deve farti sempre riflettere se quello che stai facendo sia la cura giusta oppure no. D’altro canto, anche il giocatore nel momento in cui non vince partite ha paura che la strada che tu hai scelto per lui possa non essere quella giusta e quindi mette in dubbio la tua capacità. È una cosa che a volte può fare male per un trainer, ma ti aiuta per migliorare le tue metodologie mettendole in discussione e far sì che tu possa sempre offrire il meglio a chi assisti.
Alla base di tutto sta la professionalità che offri a chi assisti, e senza dubbio questo viene percepito: sentirsi presi in cura è un diritto di chi si affida alle mani di un professionista, solo attraverso questo passaggio si può arrivare insieme al raggiungimento di determinati obiettivi.”
Molto spesso, condividere la stanza di ospedale con persone che stanno vivendo un percorso simile al tuo aiuta i pazienti e i loro familiari: vedere le giornate positive e quelle negative costituiscono la storia di molti ammalati, confidarsi le paure, accorgersi che la propria storia è comune ad altre persone aiuta molto ad affrontare le difficoltà. Tu sei stato nella tua carriera agonistica un ottimo doppista e una persona che ha vissuto molte volte l’esperienza della competizione a squadre rappresentando l’Italia in coppa Davis. Cosa ha dato alla tua vita la possibilità di condividere una sfida con altri giocatori che stessero preparando e vivendo la medesima cosa con te?
“Quando io sono cresciuto e ho cominciato a giocare a tennis, ho scelto uno sport individuale perché ero un bambino e un ragazzo a cui piaceva essere protagonista nella propria vita e anche nella propria sfida sportiva, non ero in grado di accettare il fatto che le cose non dipendessero da me; ho fatto per esempio tanti campionati studenteschi di pallavolo, ma non ero mai contento di non poter essere il protagonista assoluto dell’evento. Ho scelto il tennis perché ero da solo in campo, e perché mi piaceva sentire la sensazione che tutto dipendesse da me, nelle vittorie e nelle sconfitte. Poi invece mi sono scoperto crescendo un ragazzo molto più adatto agli sport di squadra, in maniera inaspettata, attraverso la nazionale, il senso di appartenenza, la condivisione di gioie e dolori sportivi.
Crescendo ho scoperto quanto sia bello il poter condividere con qualcuno un’impresa sportiva, una vittoria, ma anche una sconfitta; e questo mi ha cambiato anche nella vita, mi ha insegnato quanto sia importante sentire l’appartenenza ad una famiglia, ad una cerchia di affetti con cui spartire le emozioni vissute. Le vittorie più belle sono state quelle in nazionale e in doppio, e le sconfitte più dolorose sono state mitigate che ho potuto condividere in campo e fuori con chi stesse vivendo con me un’unità di intenti, una comunione di obiettivi. Capire che non sei l’unico a provare quell’emozione difficile permette di amplificare le forze.
Nella mia vita ho affrontato tante situazioni anche difficili, some peraltro qualsiasi persona del mondo, ma aver vissuto lo sport in condivisione mi ha insegnato sia a lottare, come su ogni pallina, sia a chiedere o offrire l’aiuto necessario nelle difficoltà, nelle paure. Condividere un’esperienza con qualcuno è una base irrinunciabile: nelle situazioni positive, la tua gioia si amplifica; nelle difficoltà, il tuo animo si rinfranca.”